Un risotto inaspettato, che unisce il gusto morbido delle lenticchie alle note profumate del caffè
Un vino assolutamente magico, che esiste in ben quattro tipologie tutte da scoprire: ecco il Moscato di Terracina tra storia e abbinamenti

Di recente, durante una cenetta a base di pesce, ho avuto il piacere di degustare ben freddo un vino fino a quel momento a me sconosciuto: Il Moscato di Terracina (o Terracina DOC). Tale è stata la sorpresa nel degustare una vera delizia, che ho voluto documentarmi su questo vino per raccontarvelo e invitarvi all’assaggio.
Quando parliamo del vino bianco Moscato di Terracina ci addentriamo nella provincia laziale di Latina, nella quale la viticoltura da vino è diffusa in modo particolare nell’Agro Pontino (l’antico ager pomptinus, cioè terra ricca di distese d’acqua, che poi altro non erano che le note Paludi Pontine, bonificate integralmente nel 1924 per destinarle sia all’agricoltura che ad altre attività produttive), comprendente sia Terracina che altri graziosi e molto attivi comuni. In questa zona dagli anni Cinquanta del secolo scorso si cominciò a piantare anche vigneti da vino, che nel tempo si sono rivelati capaci di produrre uve di alta qualità, che trasformate offrono ottimi vini, tra cui il Moscato di Terracina, che ha ottenuto il riconoscimento il 5 Giugno 2007. Il riconoscimento ha determinato per legge la stesura di un disciplinare di produzione, modificato diverse volte, con ultima variazione il 24 Ottobre 2014.
Portato nel Lazio dagli antichi Greci, il vitigno si può definire ormai autoctono per la provincia di Latina, per l’esattezza di Terracina, vivace comune (46.000 abitanti) posto a 22 m slm, bagnato dal mar Tirreno per tutta la sua lunghezza, con uno sviluppo costiero di circa 15 km. La diffusione di questo vitigno non ha oltrepassato i confini laziali, e fino al termine del secolo scorso la coltivazione era rara, pochi ceppi in coltivazione, spesso misti ad altri tipi da tavola.
All’inizio il Moscato di Terracina (uva bianca) era destinato alla vinificazione, in seguito si preferì utilizzarlo come uva da consumo fresco, cioè da tavola. Il grappolo di questa ottima uva è di grosse dimensioni, con forma piramidale, spargolo (cioè con acini non fitti), provvisto di una cosiddetta “ala”; gli acini sono grossi ma di misura variabile nel medesimo grappolo, sferoidali, con buccia coperta di pruina (sostanza cerosa formata da acidi grassi a catena lunga e alcol superiori come il glicerolo o glicerina, che riveste sia l’uva che altri frutti come le susine, oltre che alcune piante grasse), di spessore medio, consistente, con epidermide di colore verde-giallo e aroma delicato.
Il Moscato di Terracina è un vitigno che non presenta particolari esigenze quanto a terreno e clima, oltre ad essere resistente a molte malattie della vite e alle avversità climatiche. In linea generale, dal Moscato di Terracina vinificato in purezza (ma spesso si usa in uvaggi con altre varietà di uva bianca) si ottiene un vino bianco, con gradazione alcolica media di 11-12°, con pH 3,3-3,4 quindi con bassa forza acida (nel vino di norma 2,5 - 3,7) e 7-8 g/l e anche meno di acidità, quindi abbastanza fresco in bocca (nel vino di norma 3,3 – 15,5 g/l).
Il riconoscimento della DOC al Moscato di Terracina dimostra lo stretto legame esistente tra questo magnifico vino e l’ambiente geografico con i suoi fattori naturali ed umani, così come ben riportato e dimostrato all’art. 9 del Disciplinare, nel quale si evidenzia la produzione di vino di pregio nella zona sin dal tempo degli antichi Romani, quando Vitruvio (Marco Vitruvio Pollione , architetto e scrittore romano del I secolo a.C.), Orazio (Quinto Orazio Flacco, I secolo a.C., poeta romano) e Plinio (Caio Plinio Secondo, I secolo d.C., scrittore, naturalista e filosofo romano) lodavano il vino Cecubo prodotto in zona. Produzione che decadde successivamente ai Romani per la formazione di paludi malsane formatesi a causa dei rilevanti disboscamenti (bonificate poi a partire dai papi Leone X, Sisto V e Pio VI, successivamente dai vari governi del Regno d’Italia, specialmente negli anni trenta del secolo scorso, epoca fascista).
In base al disciplinare di produzione, il Moscato di Terracina può essere prodotto soltanto nel territorio dei comuni di Monte San Biagio, Terracina e Sonnino, area litoranea di Latina, di circa 27.500 ettari, a clima mediterraneo (quindi aridità estiva, poco freddo e solo invernale), terreni (sia calcarei, che sabbiosi, che vulcanici, che argillosi) talora pianeggianti (ma esclusi se a quote troppo basse, non idonee per una viticoltura di qualità, specialmente per la produzione di vini bianchi), talora elevati anche fino a 863 m slm, esposti in genere a Ponente, trasformando uve costituite per almeno l’85% dal vitigno omonimo (Moscato di Terracina) al quale possono aggiungersi altri vitigni a bacca bianca autorizzati per la regione Lazio, salvo che per la versione spumante nel qual caso l’uva deve essere al 100% Moscato di Terracina.
Trattandosi di un vino DOC, la coltivazione delle uve, l’appassimento (per produrre la tipologia passito), la vinificazione e l’imbottigliamento devono avvenire obbligatoriamente nel territorio sopraindicato (salvo specifiche autorizzazioni, ma sempre nella provincia di Latina), assicurando un tenore alcolico minimo dell’11% in volume. Le caratteristiche pedologiche unite a quelle climatiche, agricole e umane (capacità di coltivare bene la vite e di saperla trasformare in vino), consentono di ottenere quattro tipologie di vino (secco, amabile, passito, spumante sia secco che dolce) tutti di pregio, caratterizzate da tipico profumo del moscato (odore e aroma, dal naso il primo, perciò diretto, e dalla deglutizione il secondo, perciò di tipo retronasale), che ricordiamo essere un vitigno aromatico (come il Gewürztraminer, il Brachetto, le Malvasie), cioè caratterizzato da un ben preciso e inconfondibile profumo, dovuto all’aroma primario (cioè proprio dell’uva specifica), attribuibile nel nostro vino alla presenza di linalolo (un terpene) e altre sostanze volatili, che ricorda il profumo del muschio (da cui il termine moscato da muscum – muschio).
Non è presente solo il profumo di muschio, ma anche di fiori e frutta bianchi, e come riportato nel disciplinare di produzione, le quattro tipologie sono così caratterizzate:
- “Terracina” o “Moscato di Terracina” secco (1-5 g/l di zucchero): vino fresco ed equilibrato con colore dal paglierino al lievemente dorato, odore con note floreali, fragrante e caratteristico, sapore asciutto, aromatico tipico del vitigno; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% di cui almeno 11,00% effettivo; sapido;
- “Terracina” o “Moscato di Terracina” amabile (20-50 g/l di zucchero): vino fresco ed equilibrato con colore dal paglierino al lievemente dorato, odore con note floreali, intenso e caratteristico, sapore piacevolmente amabile, gradevole e caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% di cui almeno 11,00% effettivo; profumi di frutta a polpa gialla, esotica (banana, ananas, papaya, mango), di agrumi (cedro e limone in particolare) e di miele. La sapidità si sente perché prodotto in zona vicina al mare.
- “Terracina” o “Moscato di Terracina” passito: vino strutturato e pastoso con colore giallo dorato con riflessi ambrati, odore intenso e caratteristico, sapore dolce, gradevole, vellutato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% di cui almeno il 12,00% effettivo (il resto è quello ottenibile dagli zuccheri non fermentati, che conferiscono la dolcezza al vino);
- “Terracina” o “Moscato di Terracina” spumante: vino fresco ed equilibrato con colore giallo paglierino tenue, odore con note floreali, fragrante e caratteristico, sapore secco o piacevolmente dolce, aromatico, armonico e fresco, spuma fine e persistente; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% da brut nature a dolce.
Tutte le quattro tipologie sono caratterizzate da una notevole morbidezza, dovuta alla ricchezza di polialcoli come la glicerina, oltre che al contenuto di alcol etilico: donano una piacevolissima sensazione vellutata al palato, naturalmente in un crescendo passando dalle versioni secche alla degustazione del passito.
Il tipo secco di Moscato Di Terracina che ho avuto il piacere di bere (il pregiato Oppidum della Cantina Sant’Andrea), date le sue caratteristiche di profumo e gusto una volta in bocca, deve essere servito fresco a 8-10°C, sia come ottimo aperitivo, per poi abbinarlo indiscutibilmente a frutti di mare di ogni genere, piatti a base di pesce, prodotti affumicati della gastronomia, formaggi freschi o di media stagionatura. Il tipo amabile lo abbineremo, sempre fresco, ai dolci purché non lievitati e dalla dolcezza non troppo rilevante, mentre il passito lo useremo come vino di fine pasto a solo, oppure con dolcetti secchi a base di fichi, mandorle, datteri e simili. Lo spumante dolce lo abbineremo a dolci lievitati come colombe, panettoni, pandori e simili, mentre quello brut sarà ottimo a tutto pasto o come aperitivo con l’accostamento di degustazioni di mare ma anche tutte vegetariane.








































































































































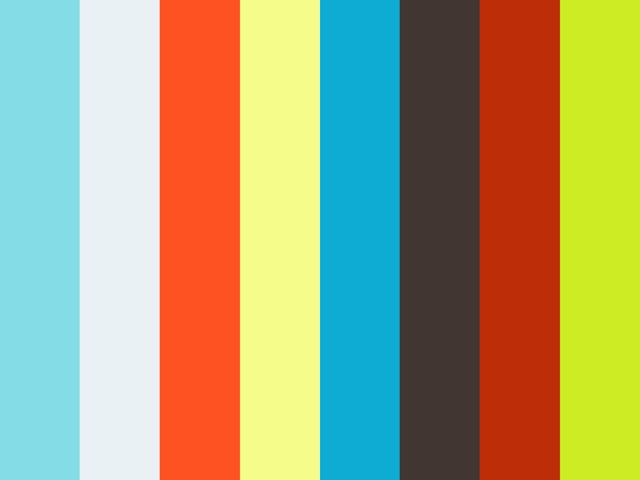
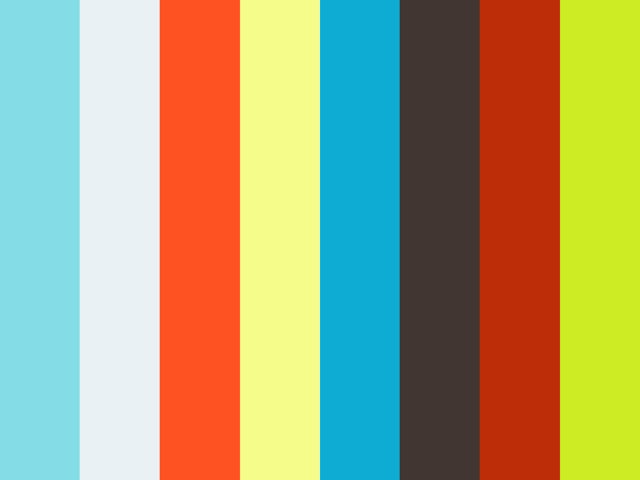
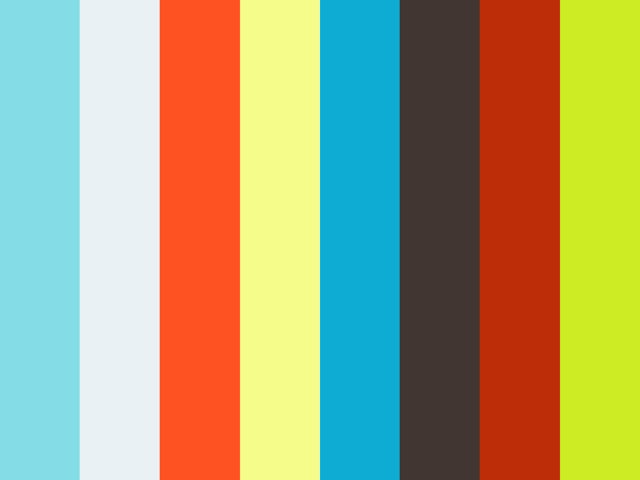
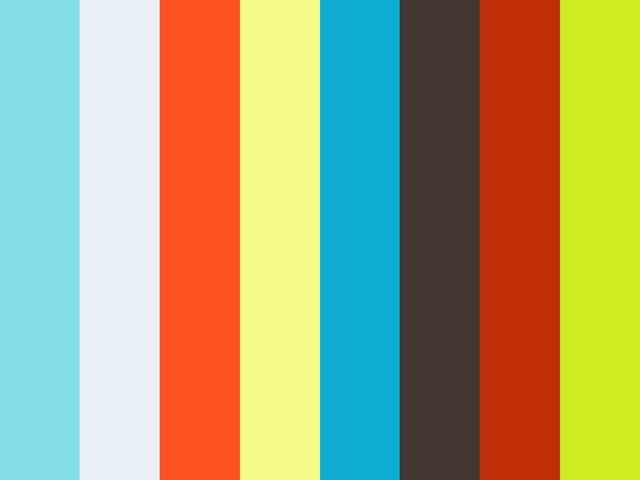
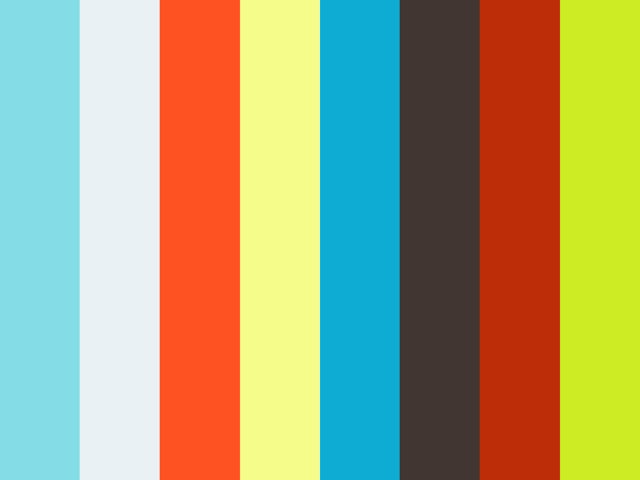
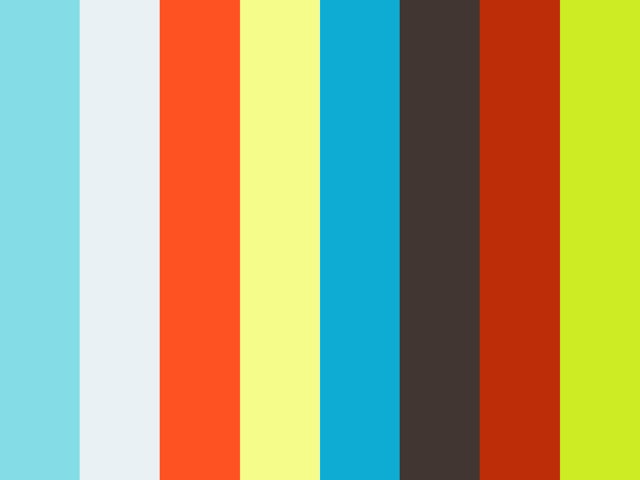

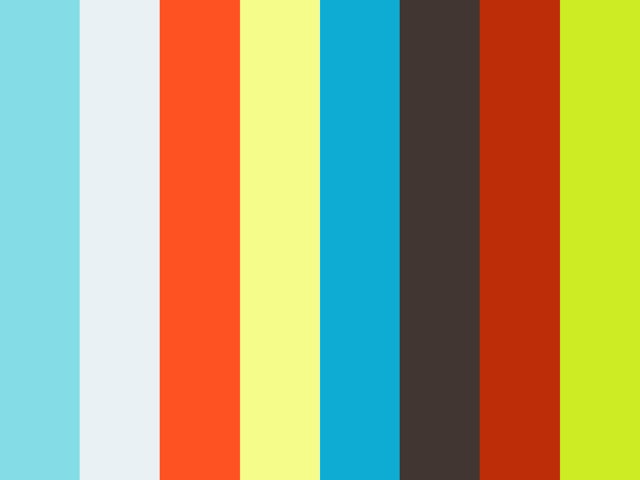

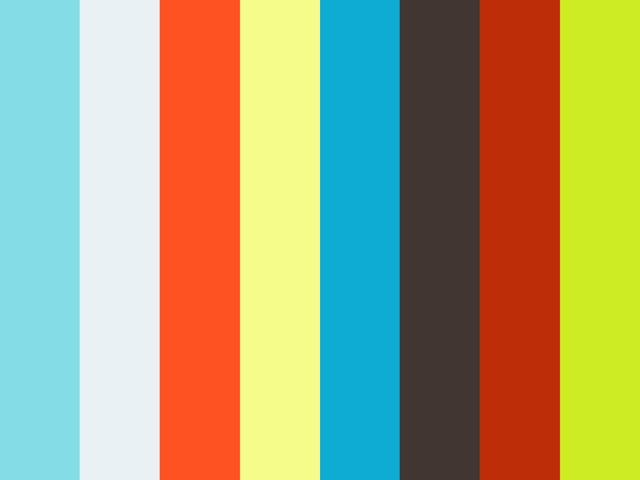
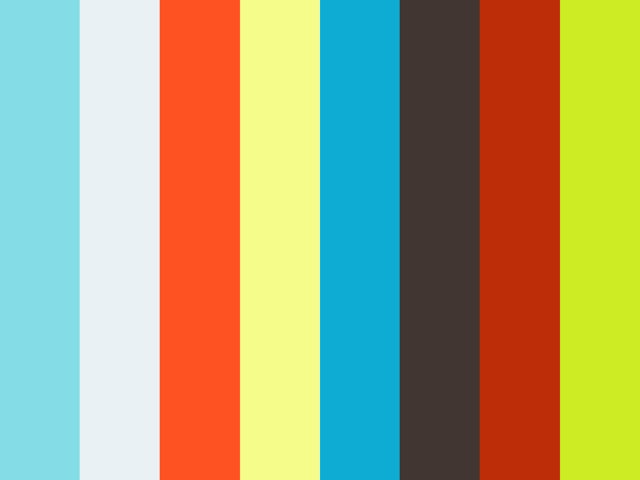
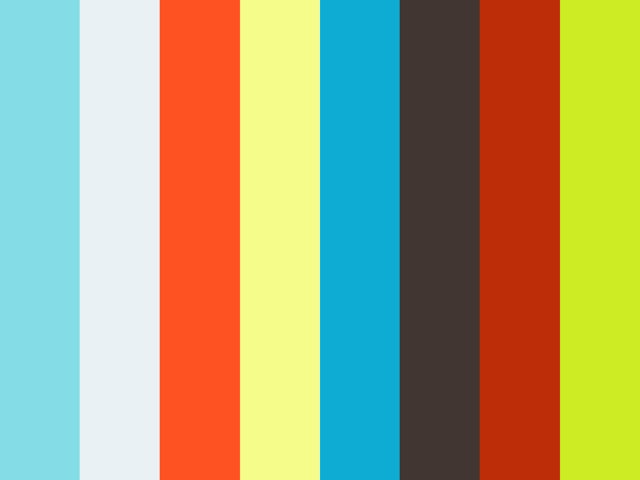
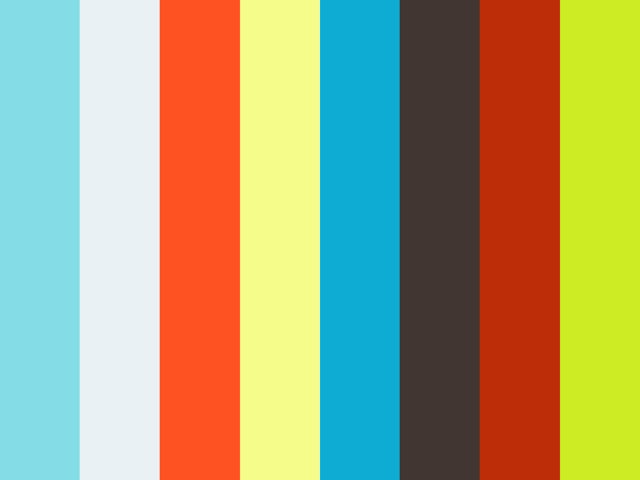
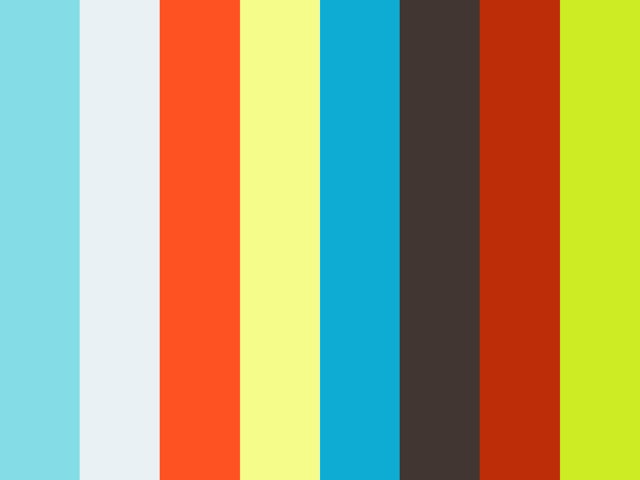
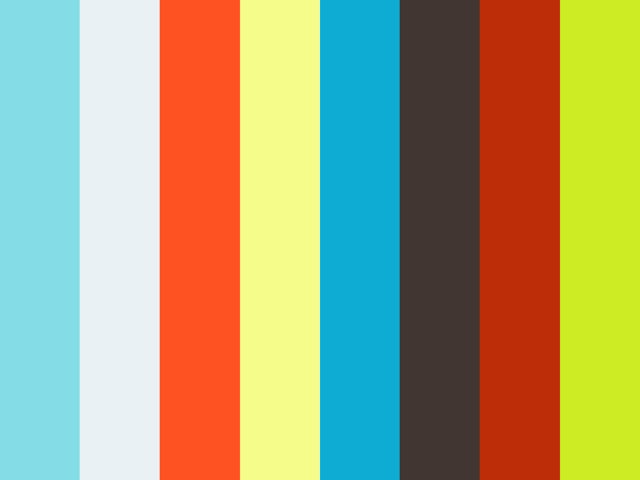
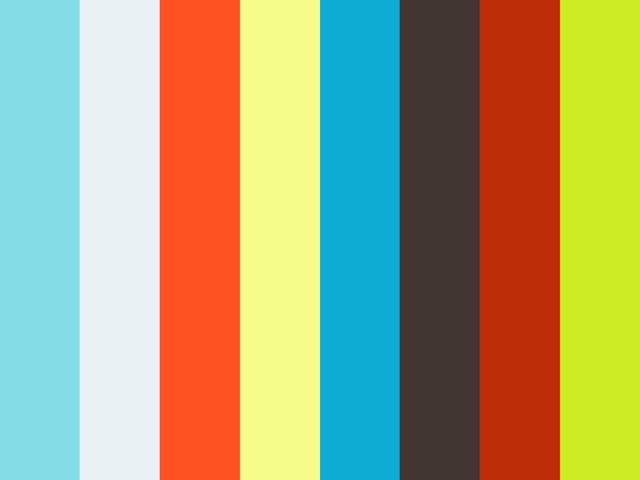
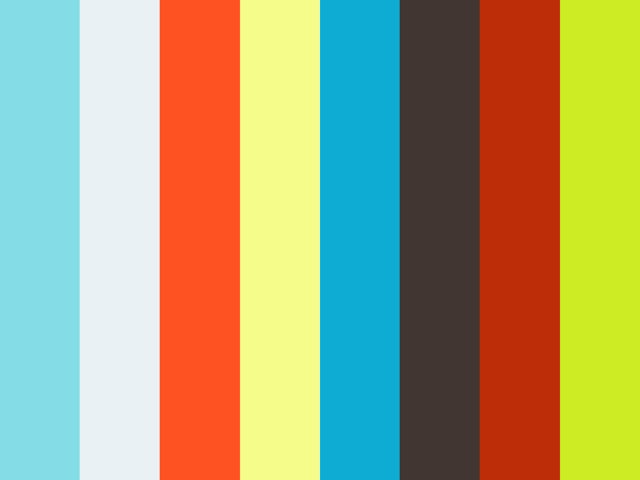





0 Commenti