Giovedì 2 maggio a "La Prova del Cuoco" con l'amatissimo chef Fabio Campoli
La denominazione di qualità che identifica un gruppo di pregiati vini, sia bianchi che rossi, tutti da conoscere e imparare ad abbinare a tavola

Vino e Lazio sono un binomio famoso nel mondo per i gli ottimi risultati enologici, in particolare per i vini bianchi, benché anche i rossi non siano da meno. In questa regione il 50% del vino è prodotto nella provincia di Roma, ricca sia bianchi che di rossi (con prevalenza dei primi); tutto ciò nonostante lo spopolamento di tante aree (specialmente i Castelli Romani), producendo comunque vini di elevata qualità, grazie alle colline e ai terreni vulcanici destinati alla viticoltura, con notevoli risultati economici per le aziende agricole e per tutti gli altri attori della filiera vitivinicola provinciale.
Roma è terra di uva e di vini, anche se a onor del vero la vite era già coltivata nella regione prima della fondazione di Roma (ai tempi di Etruschi e Latini), quando la gran parte della popolazione dell’area era dedita alla pastorizia. Va riconosciuto però che la fondazione di Roma e il suo ampliarsi a dismisura con la conquista di terre vicine e lontane, tanto da trasformarsi nel famoso Impero Romano (Europa, Africa del Nord, Asia mediterranea e oltre, fino al fiume Gange) determinò uno sviluppo grandioso della viticoltura e dell’enologia: infatti il vino serviva sia come elemento rituale/sacrificale, sia come bevanda quotidiana, pur nelle sue diverse tipologie destinate a ceti diversi, ma tutte comunque non esaltanti.
I romani e le popolazioni conquistate bevevano sì il vino, ma la scarsa qualità dell’uva (coltivata sempre maritata con altri alberi che fungevano da sostegno dei tralci) e della tecnica di trasformazione (specialmente per quanto riguarda l’igiene in cantina) davano vita a un prodotto enologico scadente, il quale doveva essere sempre corretto con miele, aromi vari e altri accorgimenti, oltre che essere molto difficile da conservare per un tempo medio/lungo, considerati i semplici/rudimentali metodi allora conosciuti per preservare il vino dalle alterazioni. Coltivazione della vite e produzione di vino a Roma si diffusero particolarmente nell’età repubblicana, ma i deludenti risultati pratici facevano sì che i romani preferissero i vini campani (Orazio cita nei suoi scritti il Cecubo, il Caleno, il Falerno, il Formiano) in quanto migliori al gusto e resistenti ai trasporti dell’epoca (sulle navi, nelle anfore), oltre che adatti a un moderato invecchiamento.
Tra i vini DOC (denominazione di origine controllata) della provincia romana (18 in tutto, su 27 dell’intera regione laziale) la più recente è la DOC ROMA (riconosciuta nel 2011), con diverse tipologie, una DOC che rispecchia in pieno tutte le caratteristiche dell’ambiente edafico e climatico, nonché le superiori capacità di coltivazione dimostrate dagli agricoltori romani e di coloro che trasformano l’uva in vino, per poi giungere al prodotto finale con tante accortezze tecnologiche e commerciali.
La DOC Roma interessa geograficamente circa 330.000 ettari (3.300 km²), circa 180 ha di vigneti iscritti alla DOC, tra specializzati e promiscui, con una produzione annuale media di circa 11.400 q di uve, corrispondenti a 110 q/ha in media, da cui si ricavano circa 1.516.000 bottiglie, corrispondenti a 1.137.000 litri di vino: numeri di tutto rispetto, tali da rendere remunerativa la scelta di produrre vino aderendo al disciplinare della DOC Roma.
L’area di produzione della DOC Roma è particolarmente vocata per la produzione di vini di notevole qualità organolettica in quanto per la maggior parte collinare (entro i 600 m di altitudine), ma anche pianeggianti, talvolta litoranei, con terreni sia di tipo sedimentario che di origine vulcanica, dotate di ottimo sgrondo delle acque anche quando pianeggianti, con escursioni termiche stagionali e giornaliere tali da ottenere uve con ricchezza di composti volatili rilevanti per l’odore (ciò che si percepisce per via nasale semplicemente annusando il vino), l’aroma (ciò che percepisce, indirettamente, il naso quando il vino attraversa la bocca e giunge nella cavità orale), il profumo (somma di odori e aromi), il bouquet (sentori acquisiti con l’invecchiamento).
Questa DOC è stata riconosciuta dall’ UE nel 2011 con il relativo disciplinare di produzione, modificato poi nel 2014 e per ultimo nel 2016. L’attuale disciplinare prevede la produzione di 7 tipologie di vino: bianco (anche amabile), rosso (anche amabile), rosso riserva (invecchiamento minimo 24 mesi dal 1° novembre anno vendemmia), rosato, Romanella (spumante), Malvasia puntinata (vitigno prevalente nell’uvaggio), Bellone (vitigno prevalente nell’uvaggio), con indicazione della menzione “classico” solo per quelli prodotti nella zona di origine più antica (alcune parti del comune di Roma).
I tipi bianco e Romanella devono essere prodotti almeno per il 50% dal vitigno Malvasia b. del Lazio (Malvasia deriva da Monemvasia, porto greco utilizzato dai Veneziani fin dal XI sec. per imbarcare vino bianco da vendere in Europa settentrionale) e per il resto da altri vitigni bianchi riconosciuti dalla Regione Lazio (Bellone, Bombino, Greco b., Trebbiano giallo e T. verde); per quelli rosso e rosato bisogna utilizzare almeno per 50% uva Montepulciano (dal nome dell’omonimo comune in provincia di Siena), per il resto altri vitigni rossi regionali come: Cesanese comune, Cesanese d’Affile (Cesanese deriverebbe da “cese”, dal latino “caedo” cioè io taglio, probabilmente perché con quest’ uva nera si correggevano i difetti di altre uve da vino [con l’uvaggio], o miscelando i vini pronti [vinaggio]), Sangiovese, altri; per i tipi Malvasia puntinata (o Malvasia col puntino, malvasia gentile, malvasia nostrale, tipica per gli acini di colore giallastro con punteggiature e macchie marroni; per alcuni sinonimo della Malvasia del Lazio) e Bellone (bianco, detto anche Cacchione/Arciprete; già conosciuto al tempo dei Romani, citato da Plinio come “tutto sugo e mosto”) è necessario che i vitigni citati concorrino rispettivamente almeno per l’ 85%, mentre altri vitigni bianchi regionali possono partecipare al massimo per il 15% (si tratta quindi di vini prodotti volend in purezza se i due vitigni citati dovessero rappresentare il 100% dell’uva vinificata).
La zona di produzione delle uve, di trasformazione in vino e imbottigliamento (solo per quest’ultima fase è permessa l’effettuazione nel comune di Aprilia) per questa DOC interessa quasi tutta la provincia di Roma (escluse alcune a nord, a est, e a sud est), comprendendo ben 63 comuni sui 121 totali, ma tali da rappresentare come superficie circa il 70% dell’intera provincia romana. Il disciplinare fissa in 120 q/ha e in 100 q/ha le produzioni di uva rispettivamente per i bianchi e i rossi/rosati, con un contenuto zuccherino tale da consentire una gradazione alcolica di almeno 11° per i bianchi (quindi almeno 16,66° zuccherini), 11,5° per rossi e rosati (quindi almeno 17,42° zuccherini), 9° per lo spumante Romanella (quindi almeno 13,64° zuccherini).
La commercializzazione del tipo bianco e del Romanella può iniziare a partire dal 15 marzo post vendemmia, mentre rosso e rosato dal 31 marzo post vendemmia. Il bianco presenta una gradazione alcolica minima di 12°, colore giallo paglierino con eventuali riflessi verdognoli, odore delicato, floreali (fiori bianchi e gialli), appena fruttati (frutta bianca), sapore asciutto (cioè secco, per niente dolce) e armonico; passando al bianco amabile la gradazione passa a 12,5°, quanto all’odore è presente la decisa nota fruttata (frutta bianca/gialla matura, confettura di frutta bianca), per il sapore si avverte l’amabile (si dice di un vino nel quale si avverte chiaramente la dolcezza, ma questa non è predominante tra le sensazioni gustative; corrisponde a un contenuto zuccherino compreso tra 20 e 50 g/l), una maggiore sapidità (dovuta alla presenza di sali quali fosfati, solfati, cloruri, ecc. derivati dalla salificazione degli acidi organici del mosto, come l’acido tartarico, malico, citrico,ecc.).
Il tipo rosso, con alcol di 12,5°, presenta colore rosso rubino con riflessi violacei, i quali virano al granato con l’invecchiamento, odore tipico di frutta rossa e matura, intenso al naso, sapore secco, armonico (quando le componenti organolettiche visive, olfattive e gustative si combinano perfettamente, con grande equilibrio), con buona struttura (dovuta a ciò che resta se dal vino si elimina acqua, alcool e altre sostanze volatili, quindi a tutte le sostanze non volatili come glicerina, sali minerali, gomme, pectine, tannini, ecc.; si avverte in bocca come consistenza del vino), abbastanza persistente in bocca (sapore e profumi retro nasali restano in bocca per circa 4-6 secondi).
Nel tipo rosso amabile emerge l’alcol con i suoi 13°, nell’odore la nota fruttata (frutti rossi e maturi, confetture di questi), nel sapore l’amabile prima descritto, mentre nel rosso riserva (min. 24 mesi di maturazione) il colore più che rosso rubino passa al granato, l’odore è più fruttato, etereo (eteri, eteri, acetali si formano durante l’invecchiamento, sono odori terziari), il sapore più ricco di persistenza, con morbidezza maggiore grazie alla trasformazione dei tannini verso tipi meno astringenti, oltre che ad alcoli e glicerina.
Molto interessante lo spumante Romanella che si presenta con minimo 11° alcolici, di colore giallo paglierino tenue, con una spuma fine (le bollicine hanno la dimensione della punta di spillo) ed evanescente (le bollicine durano poco, solo alcuni secondi), brillante quanto a limpidezza (cioè oltre a essere cristallino, riflette intensamente i raggi luminosi, grazie proprio alla rifrazione sulla superficie delle bollicine), odore abbastanza intenso, abbastanza persistente, sapore da brut (zuccheri 6-15g/l) a extradry (zuccheri 12-20g/l), fresco (decisa sensazione di acidità che determina abbondante salivazione).
Senza dubbio le eccellenti caratteristiche organolettiche dei vini DOC Roma sono da attribuire non solo all’ambiente geografico, ma anche alle capacità degli agricoltori quanto a metodi di coltivazione della vigna, vitigni scelti e bravura nella trasformazione dell’uva in vino, seguendo sia la tradizione di zona che utilizzando moderne tecniche e tecnologie enologiche, con grande attenzione all’igiene in cantina. Nel disciplinare (modificato nel 2016) attualmente in vigore, all’art. 9 è descritto in maniera eccellente tutto ciò che riguarda l’ambiente climatico, i terreni, i vitigni, con citazione di aspetti storici della coltura e cultura della vite e del vino dall’antica Roma, nei diversi secoli fino all’attualità: una descrizione veramente illuminante.
Il Roma DOC Bianco secco è ideale se abbinato ad antipasti di mare, pesce (in particolare se bollito, cotto in courtbouillon o al vapore), molluschi e crostacei, primi piatti saporiti a base di pesce e altro di mare, carni bianche, eccellente come aperitivo. Ottimo con preparazioni varie di uova (es. alla coque), mozzarella e pomodoro, pizza e preparazioni simili, funghi. Per l’abbinamento delle tipologie Malvasia Puntinata e Bellone bisognerà tenere conto delle superiori caratteristiche di odore e profumo di questi due vini bianchi prelibati, per cui anche le preparazioni dovranno essere all’altezza quanto a profumo del piatto.
I Roma DOC rosso, rosso classico, rosso riserva esaltano cibi della tradizionale romana: carni grigliate, ricette di trippa (famosa quella alla romana), coda alla vaccinara, formaggi e salumi, scegliendo per le preparazioni più complesse i DOC Roma rosso più maturi. Le tipologie amabili si abbinano di solito a dolci da forno, biscotteria secca a base di frutta secca, pasta di mandorla e simili, evitando i lievitati tipo panettone e pandoro per i quali è più indicata la tipologia spumante dolce.
La tipologia spumante risulta essere valida a tutto pasto, destinandola però ad abbinamenti con preparazioni delicate citate per il tipo bianco secco, escludendo perciò preparazioni caratterizzate da succulenza e untuosità. Inoltre va detto che la maggiore acidità/freschezza dello spumante si abbinerà a pietanze dotate di grassezza e tendenza dolce, mentre non si abbinerà ai dolci e simili (sia da forno che lievitati) in quanto spumante non dolce.
Note bibliografiche
S. Severi, Il vino a Roma e nel Lazio, Edilazio
Disciplinare modificato della DOC Roma
Tecnica dell’abbinamento cibo vino, AIS
Tecnica della degustazione, AIS
Photo via Canva








































































































































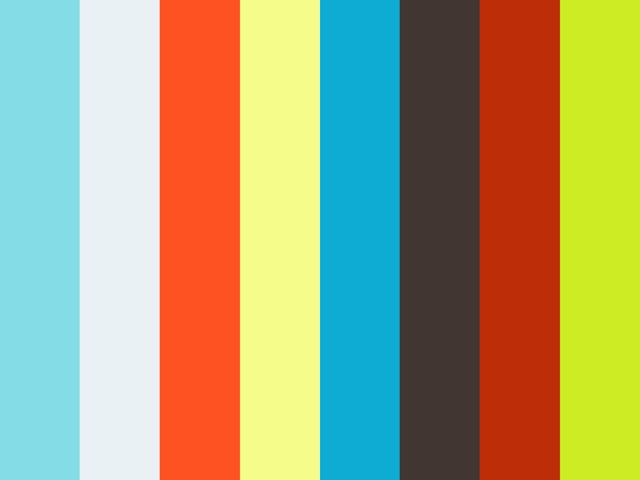
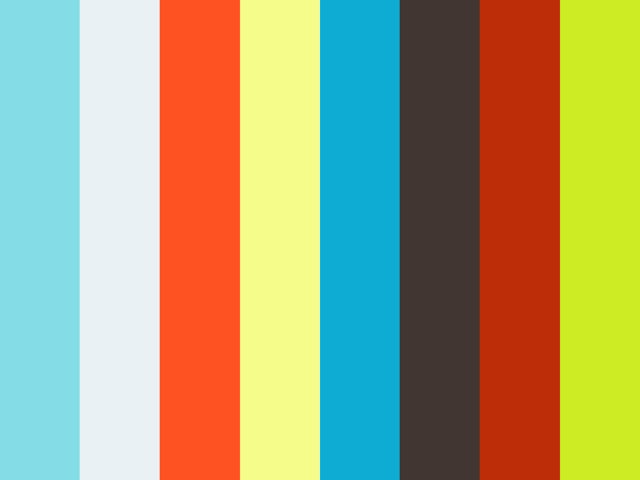
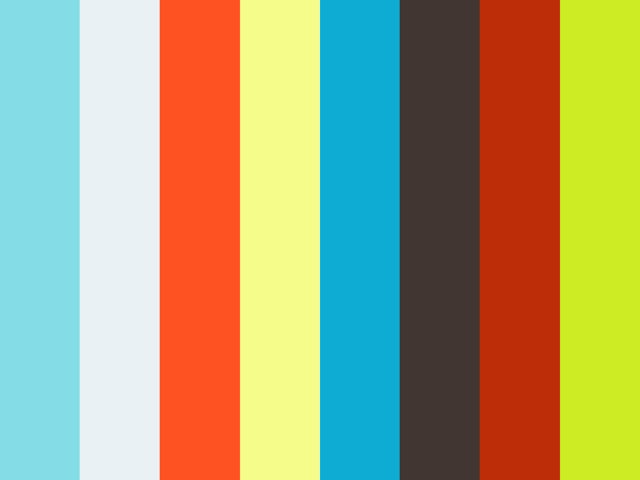
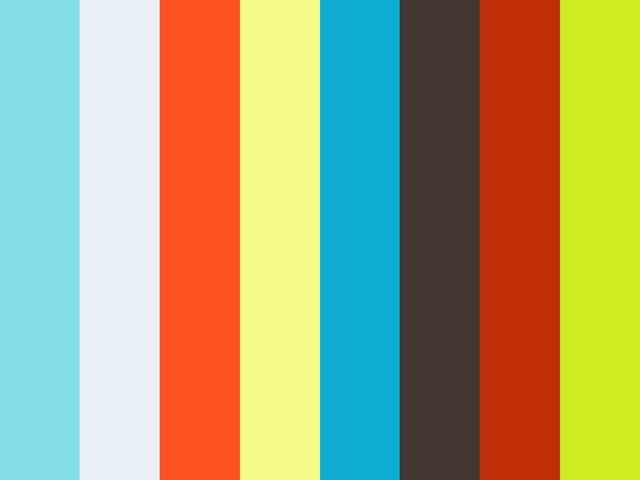
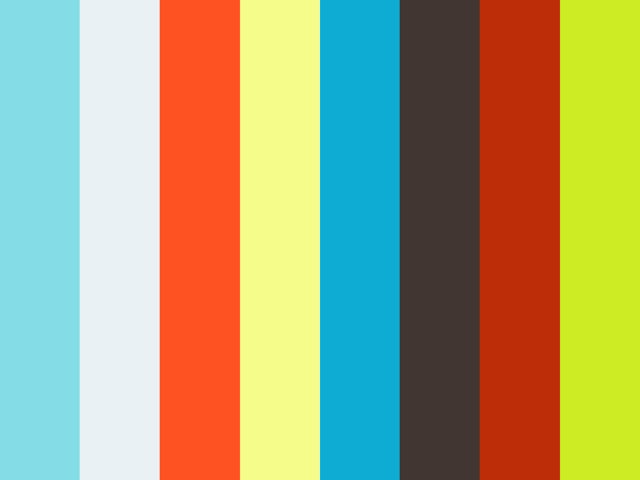
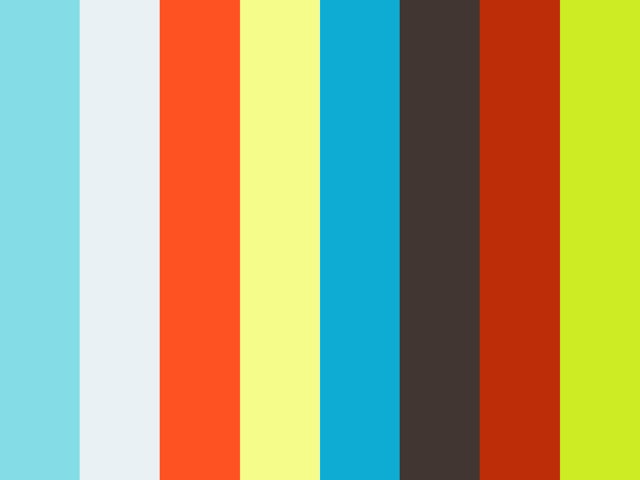

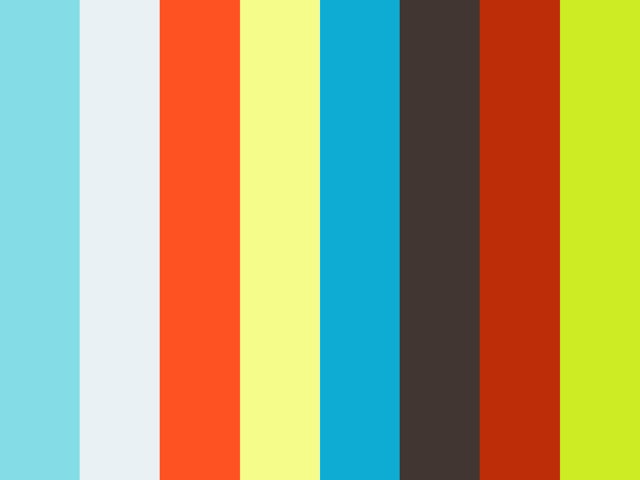

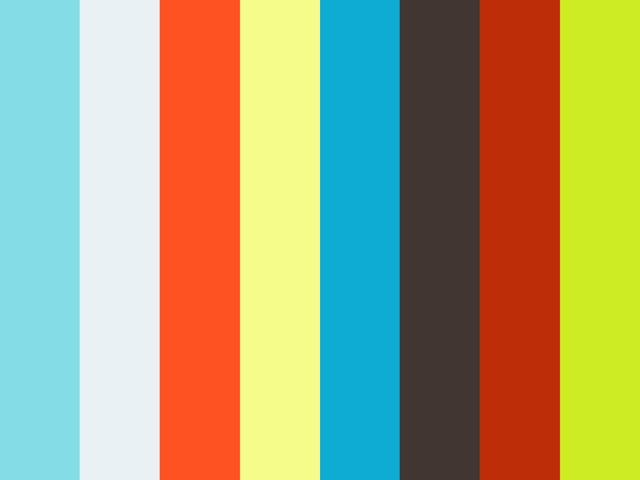
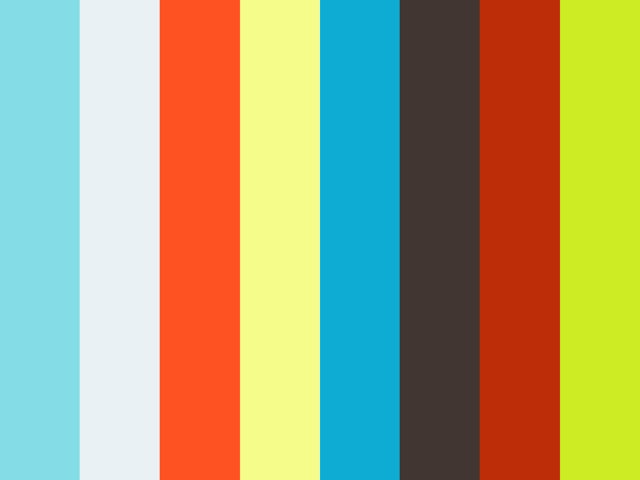
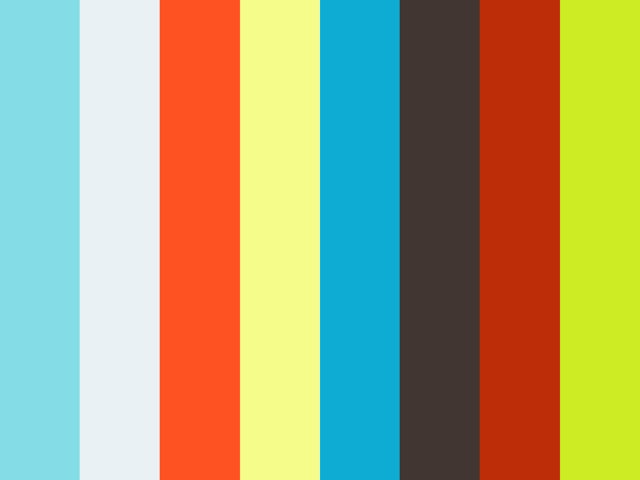
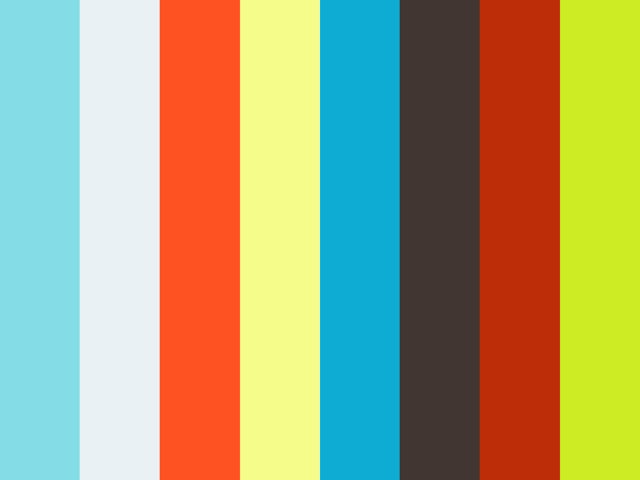
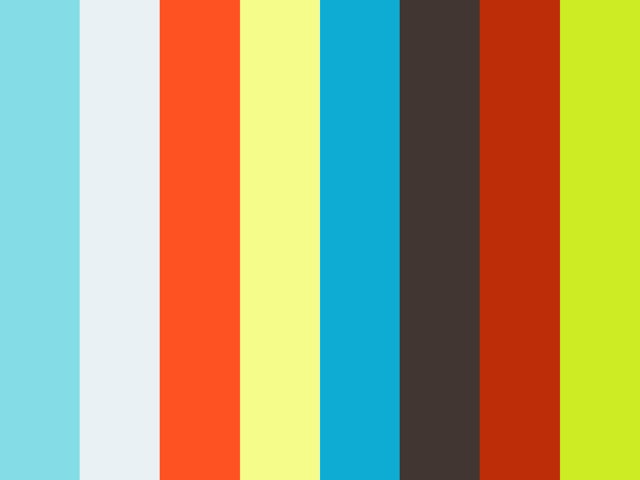
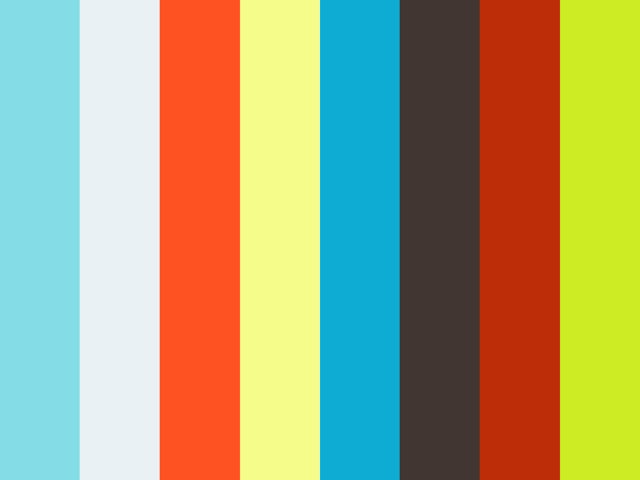
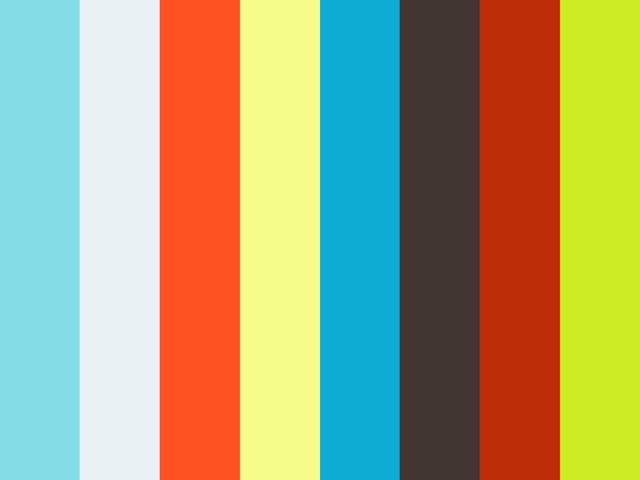
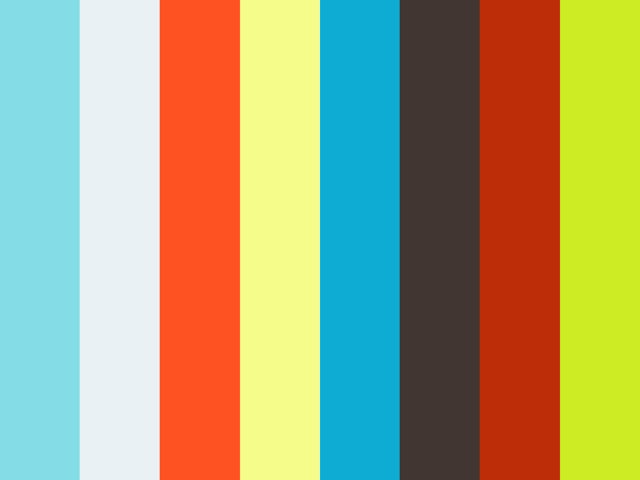





0 Commenti