Le grandi personalità femminili che, dopo secoli di silenzio, hanno lasciato l’impronta con i propri manuali di ricette
Una “corrente di pensiero” che ha fatto la storia nella cucina italiana del Novecento: il futurismo di Marinetti e Fillìa

“Marinetti dice Basta! Messa al bando sia la pasta.
Poi si scopre Marinetti che divora gli spaghetti!”Ettore Petrolini
Filippo Tommaso Marinetti - Fillìa, La cucina futurista, Il Formichiere Editore, 296 pagg.
Dici cucina futurista e rischi il pernacchio di partenopea memoria. Per decenni il Manifesto della Cucina Futurista e le tante attività realizzate complessivamente dal Futurismo sono stati viste e interpretati quasi unicamente come provocazioni, esagerazioni, goliardate nel solco di una generale sottovalutazione e/o travisamento del movimento fondato nel 1909 da Filippo Tommaso Marinetti, antesignano delle avanguardie storiche che via via verranno a caratterizzare l'arte del XX secolo.
Il Futurismo sin dall’inizio non ebbe vita facile e fu oggetto di molte critiche. Gli animi esacerbati del dopoguerra e le contrapposizioni politico-ideologiche non favorirono uno studio oggettivo e, (figuriamoci!) ancor meno dei temi che riguardavano il testo dello specifico Manifesto dedicato alla cucina che, a nostro parere, non è una semplice appendice e provocazione estemporanea, ma costituisce una delle componenti più originali e anticipatrici del movimento nel suo complesso. Non è privo di significato che l'antipasto della sperimentazione gastronomica era avvenuto già dopo la serata del 1910 al Teatro Politeama Rossetti di Trieste, con una cena a rovescio iniziata con il caffè. Per l'occasione venne bandito l'uso delle posate e i piatti tradizionali ebbero nomi di fantasia, come lo Spezzatino di passato con piselli esplosivi in salsa storica.
Apparve chiaro da questa estemporanea iniziativa, decenni prima della pubblicazione del manifesto sulla cucina, che le questioni gastronomiche riguardavano i temi di questa avanguardia artistica. Del resto il Manifesto di Marinetti e Fillìa (pseudonimo del poeta e pittore Luigi Colombo, ndr), che verrà edito anni dopo, si inserisce in un filone che dedicava attenzione nei confronti del cibo e della cucina, nel fervido mondo dei movimenti artistici a cavallo tra la fine dell'Ottocento e i primi anni del nuovo secolo. Si conoscono ad esempio dall'epistolario di Claude Monet gli interessi gastronomici non solo conviviali degli impressionisti già alla fine del XIX secolo; e già nel 1913, ovvero pochi anni dopo la nascita della corrente del Futurismo, Guillaume Apolinnaire, considerato un autentico “esprit provocateur” la cui influenza si avverte in tutti i movimenti della letteratura francese dal 1905 al 1920, sostenne la necessità dell’incontro tra l’Arte d’avanguardia e l’Arte culinaria, in un articolo sul giornale satirico “Fantasio”, dal titolo “Le Cubisme culinaire, le Gastro-Astronomisme ou la Cuisine nouvelle”.
A Parigi, In quelle stesse settimane del 1913, un giovane cuoco prova a sfondare la gabbia dei dogmi dell'alta cucina, a suo dire imperniata su di un numero limitato di ricette, sempre uguali e senza più fantasia. Anche lui, personaggio esagerato e geniale, Jules Maincave, ambiva essere uno sperimentatore. Egli riteneva la cucina basata sui "metodi tradizionali delle mescolanze" monotona sino alla stupidità". Secondo lui la Cucina senza sperimentazione era inadatta all’epoca che il Mondo stava vivendo, epoca portatrice di scienza, progresso e velocità. Non erano forse nate per questo le Avanguardie artistiche nella pittura, nella letteratura, nella musica? E allora perché non dovevano esistere delle Avanguardie nella Cucina?
Nonostante l'importante contributo di studiosi e pubblicazioni (su tutte citiamo Marinetti, padre della nouvelle cuisine di Claudia Salaris e Cucina futurista di Guido Andrea Pautasso), continuano gli equivoci che ancora alimentano la disinformazione sul fenomeno della cucina dei futuristi in maniera semplicistica e riduttiva, senza affrontarla oggettivamente dal punto di vista storico, culturale, sociale e ancor meno rispettando la cronologia, per altro complicata, degli avvenimenti ad essa collegati e dall'accavallarsi delle diverse tappe di elaborazione delle tematiche. Oggi il giudizio sul Futurismo ha infatti superato gli anatemi politici e ha distinto vicende personali e contesti storici dall'effettivo valore e influenza su tanti e tanti aspetti della cultura e dell'arte del Novecento e non solo italiana. Qui non vogliamo e non possiamo ragionare sulla complessità dell'avanguardia artistica nel suo complesso, perché riguarderebbe poco o nulla le tematiche di questa rubrica, ma intendiamo ragionare e mettere nella giusta luce le intuizioni e le anticipazioni avanzate dalla teoria e dalla pratica futurista nei confronti della cucina e del gusto.
Marinetti tradusse il “Manifeste de la cuisine futuriste” di Maincave del 1913 soltanto quattordici anni dopo, per pubblicarlo con il titolo “La cucina futurista. Manifesto della cucina futurista” sulla rivista “La Fiera Letteraria” nel maggio del 1927. Ma solo tre anni dopo, il 28 gennaio del 1930, venne pubblicato sulla Gazzetta del Popolo di Torino, redatto personalmente da Tommaso Marinetti, il testo nuovo, originale e definitivo del “Manifesto della cucina futurista”, per poi comparire sulla rivista “La Cucina Italiana. Giornale di gastronomia per le famiglie e i buongustai” il 15 gennaio del 1931. Arriviamo infine alla pubblicazione definitiva del volume La cucina futurista del 1931, edito a Milano da Sonzogno e di cui riportiamo all'inizio la copertina originale della ristampa contemporanea. La pubblicazione del libro ebbe subito grande risonanza, grazie anche al talento comunicativo e alle iniziative che Marinetti realizzò e il libro fu rapidamente tradotto in inglese, francese, tedesco, spagnolo e norvegese. Il Manifesto fu celebrato da Marinetti nel menu offerto ai commensali in occasione dell’inaugurazione del ristorante futurista ‘Taverna Santopalato’ in via Vanchiglia 2 a Torino l’8 marzo dello stesso anno.
Marinetti, a distanza di circa vent’anni da Maincave, sognava la trasformazione della cucina grazie all’uso della tecnologia e delle scoperte scientifiche dell’era moderna. Per questo, a differenza del collega francese, imprime una dimensione socio-culturale unita alla sottolineatura degli aspetti tecnici e scientifici secondo la poetica generale del Futurismo. Inoltre, in un'ultima fase (quella della “polemica contro la pastasciutta”), le idee si sposano alla propaganda e alla retorica del fascismo, diventato sempre più bellicoso e teso a condizionare il privato e la vita degli italiani in funzione dei venti di guerra che agitavano l'Europa.
Nel periodo dal 1930 al 1944, con un’economia sempre più autarchica, il riso rappresentava un bene nazionale che poteva equilibrare le importazioni di grano. "Questi sono piatti da vecchi borghesi. Prepariamo una agilità dei corpi italiani adatti ai leggerissimi treni di alluminio..." scriveva Marinetti. Sul finire degli anni '30, con la guerra alle porte e con l'autarchia, gli italiani cominciano a tirare la cinghia e Marinetti affrontò cinicamente la questione, affermando che bastava supplire alla mancanza di denaro con la fantasia e rendere presente che l'arte culinaria è nobile e attraente, come la poesia, la musica, la pittura, l'architettura. Il dramma della guerra e la durezza del vivere quotidiano svela in questi anni il limite della grande capacità affabulatoria e comunicativa e ne oscura, per la crescente compromissione con il regime, i pur tanti risultati raggiunti. La questione della pastasciutta troverà una sua collocazione in questo contesto di politica autarchica, che il futurismo anticipò proclamando: "Ricordatevi poi che l'abolizione della pastasciutta libererà l'Italia dal costoso grano straniero e favorirà l'industria italiana del riso".
Oggi la lettura del volume a ristampa dell'originale Manifesto, nonché dei due saggi citati in questo articolo della Salaris e di Pautasso, danno bene l'idea dell'impegno propagandistico e permettono al lettore di capire a fondo la portata e il significato del discorso futurista che, per tanti versi, anticipa orientamenti e idee che oggi sono date per scontati, ma che allora erano assolutamente dirompenti rispetto ai canoni della cucina e dei comportamenti alimentari tradizionali. I testi dei due autori offrono l'opportunità di un vero approfondimento raccogliendo, nell'arco temporale dal 1909, anno d'inizio del Futurismo, al 1944, anno della morte di Filippo Tommaso Marinetti suo ideatore, fondatore, diffusore e mistagogo un'ampia e articolata documentazione, anche grafica, sui temi della cucina futurista. Gli autori, pur con metodi diversi, non si limitano a riportare testi, manifesti e materiali, ma sviluppano un viaggio ragionato tra letteratura e gastronomia corredato da un ricco materiale d'epoca tra cui ricette e descrizioni di banchetti futuristi, immagini, prose e poesie sul cibo, utilizzando una più ampia e articolata pluralità di fonti e documenti che ci permettono di capire e interpretare il vero carattere anticipatorio delle idee e delle sperimentazioni che intrapresero i cuochi nei decenni a venire.
Come scrive Claudia Salaris: "Rivoluzionare l'arte per cambiare la vita: ecco la motivazione che ha indotto i Futuristi a ingaggiare innumerevoli crociate, tra cui memorabile quella contro la pastasciutta. Tuttavia, non ne capiremmo veramente lo spirito se pensassimo esclusivamente alla provocazione di un movimento in continua sfida al gusto corrente. La cucina futurista trasforma il cibo-di più l'atto di nutrirsi- in spettacolo a sorpresa coi commensali come attori e le pietanze come opere d'arte, anticipando così i più recenti esiti artistici e anche la nouvelle cuisine".
In sintesi, alla conclusione del suo percorso che come abbiamo visto si articola per quasi tre decenni, il pensiero futurista ha due bersagli: la grande cucina delle élites che si consumava soprattutto nei grandi alberghi e gli usi e le abitudini più tradizionali della cucina di casa. Nonostante Marinetti abbia pietosamente fallito la battaglia contro l'emblema dell'italianità per eccellenza, ovvero la pastasciutta, ha in realtà intuito e aperto la strada ad argomenti quali la nouvelle cuisine, la cucina molecolare, lo stile dei cuochi avanguardisti, la nutrizione consapevole con simpatie vegetariane, l’innovazione tecnologica entrata oggi nelle cucine di tutti, non solo dei professionisti. Una lettura, la sua opera, ancora oggi di grande interesse e attualità anche per i professionisti della cucina che hanno modo di conoscere percorsi e idee del loro complesso ambito professionale. Pensiamo infatti che a fare il cuoco (ma anche il giornalista, per non citare gli altri numerosi mestieri che oggi afferiscono al mondo della gastronomia) non basti la sola competenza professionale, ma che servano anche le coordinate più ampie della storia e della cultura gastronomica. In questo concordiamo con il Pellegrino nazionale sul fatto che la cucina sia scienza e insieme arte come nel titolo del suo storico trattato nazional-popolare.
il Manifesto, letto oggi, stupisce se si pensa al contesto storico della gastronomia nei primi decenni del secolo scorso. Ancora c'è sempre un più o meno piccolo sussulto di ironica compiacenza quando si accenni alla cucina futurista, considerata dai sedicenti colti e da alcuni addetti ai lavori una provocazione o poco più. Non è così se pensiamo ai riconoscimenti che Marinetti dà alla cucina, ponendola sullo stesso piano delle manifestazioni artistiche del genio umano come la pittura, la poesia, l'architettura. I miei pochi e affezionati lettori sanno quanto questo sia l'aspetto che più ci sta a cuore in questa rubrica.
Scritto da Sergio Bonetti
Ha insegnato all'Università, si è occupato di piccole imprese e, negli ultimi anni, soprattutto di quelle del settore enogastronomico, per le quali ha promosso eventi legati alla cultura del territorio. Le sue grandi passioni sono i libri, il cibo, il vino…e le serie tv.
Ama viaggiare e per lui ogni tappa diventa occasione per visitare i mercati alimentari e scoprire nuovi prodotti, tecniche e tradizioni.
E’ inoltre appassionato di ricerca e dello studio di testi in ambito culinario, per contrastarne la spettacolarizzazione e i luoghi comuni.








































































































































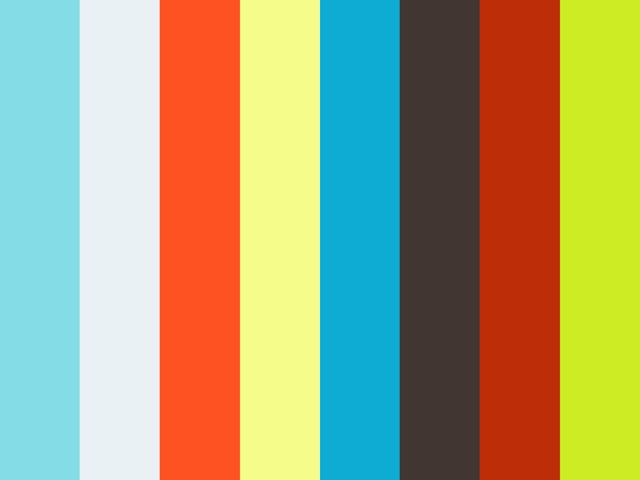
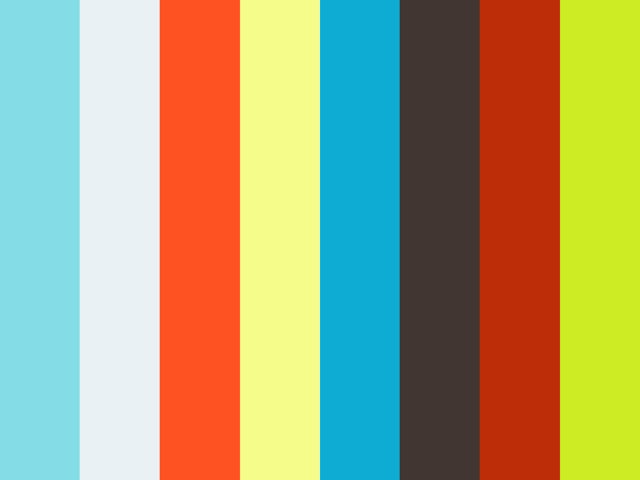
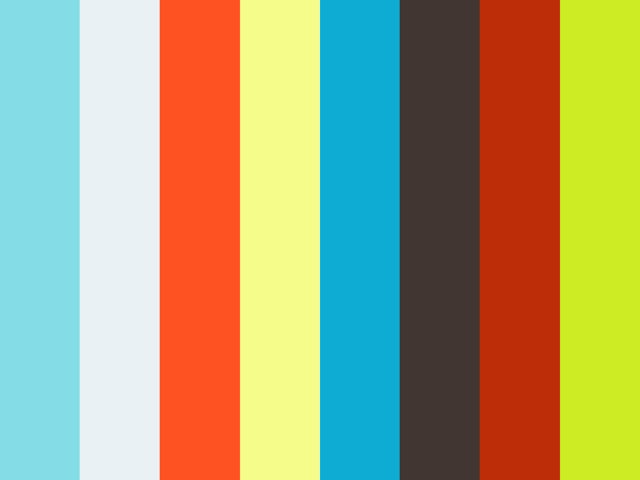
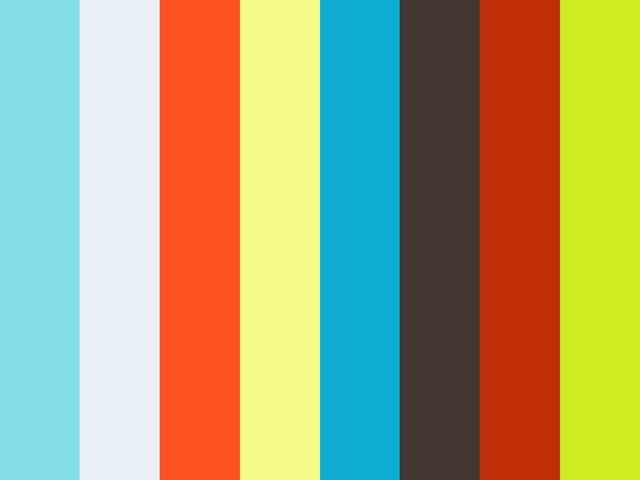
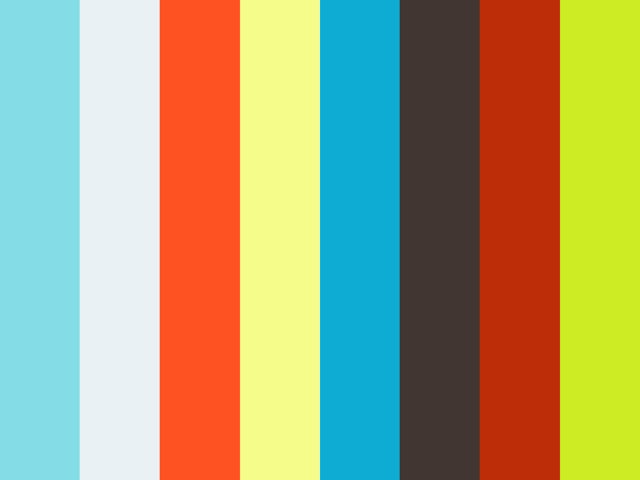
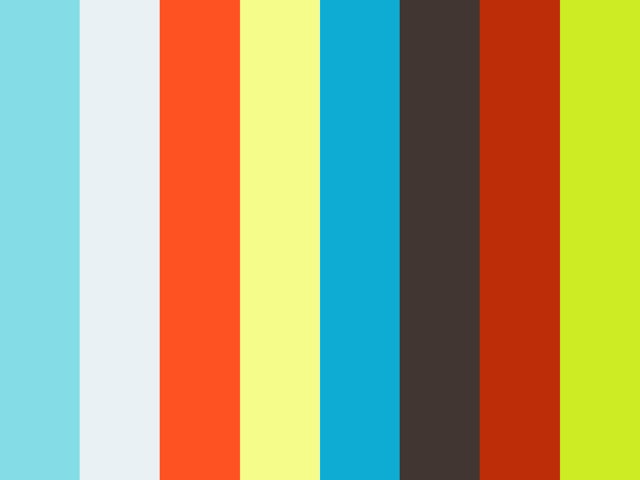

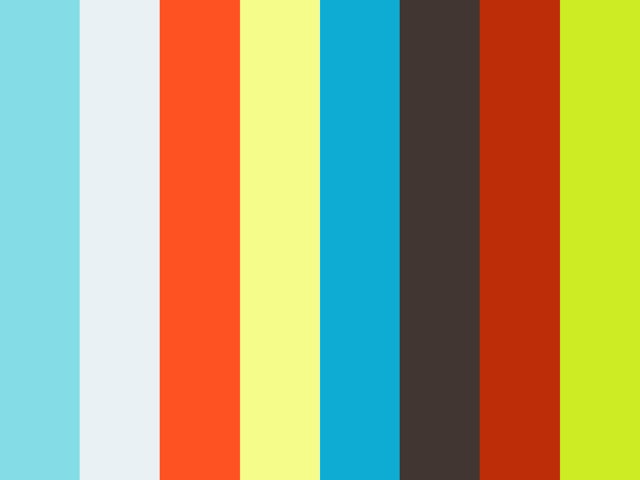

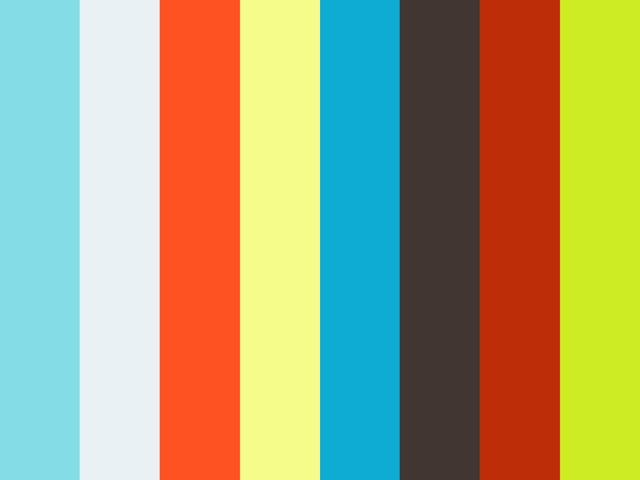
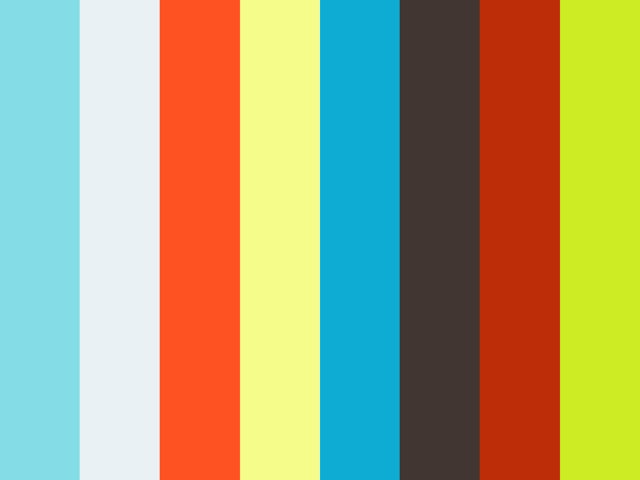
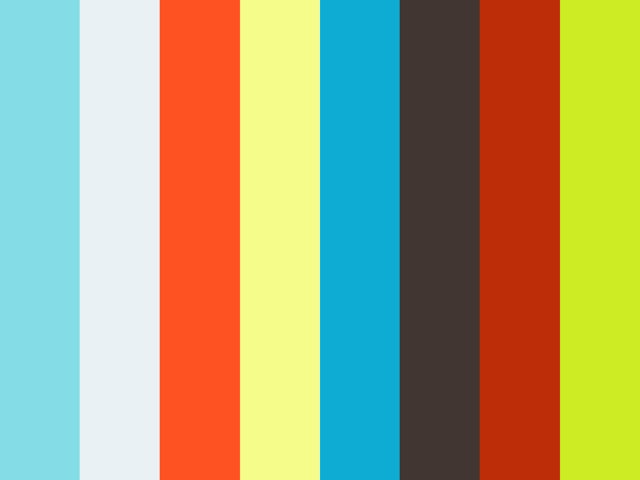
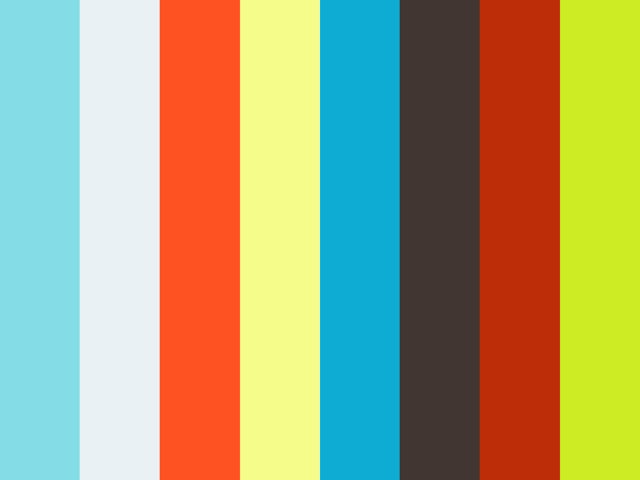
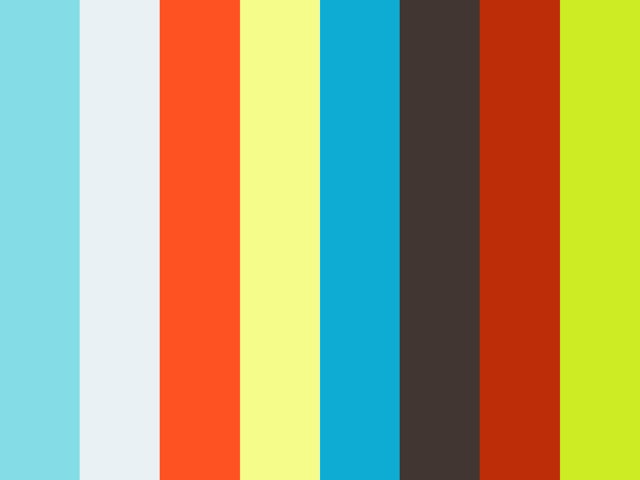
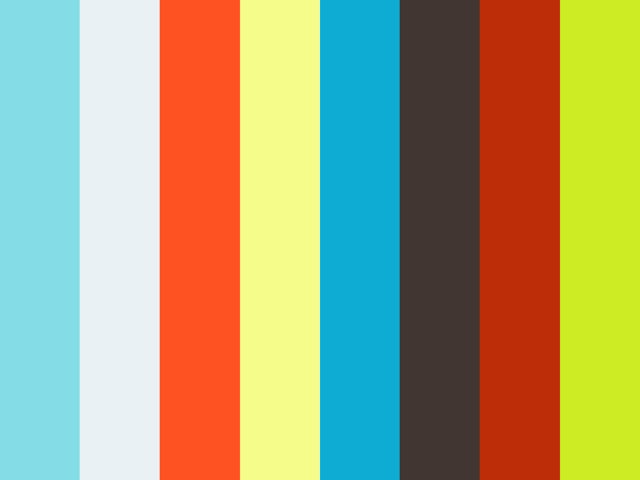
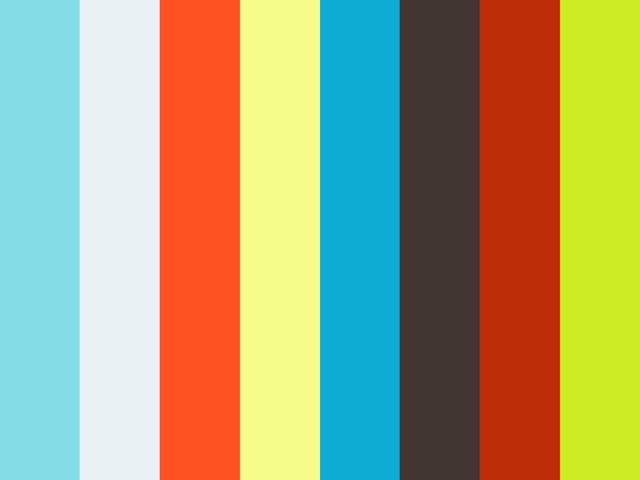
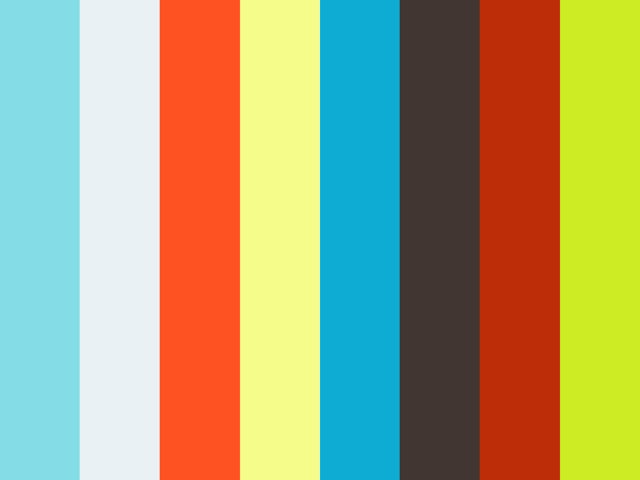





0 Commenti