La patata “dolce” o “americana” come ingrediente che può giovare alla nostra salute... con grande gusto!
Selvatica o coltivata, più piccante o più dolce, appartiene alla famiglia delle crucifere: conosciamone storia, proprietà e usi

Quando si parla di rucola il mio ricordo va a mia madre, perché la rivedo mentre con tanta pazienza (ma senza perdere tempo) staccava le tenere foglioline di rucola dagli steli delle piantine acquistate al mercato. Il mio ricordo va anche a noi piccini di casa, ai quali la mamma assegnava il compito di sostituirla in questa operazione, così come nel grattare il formaggio o spezzettare una pasta lunga. Tutti ricordi di un tempo (non tanto lontano) nel quale la fretta non alloggiava nelle case, e le faccende affidate ai piccoli dovevano comunque essere fatte bene. La rucola che ricordo non era certamente quella coltivata, che oggi troviamo sulle bancarelle del mercato rionale, ma quella spontanea raccolta (dai fruttivendoli), insieme ad altre erbe da bollire, girando negli incolti sparsi attorno alla città o nelle campagne.
Abbiamo quindi detto sostanzialmente che di rucola ne esistono due tipi: uno coltivato ed uno spontaneo. Il primo tipo è la Eruca sativa (cioè coltivata) o ruchetta (secondo alcuni questa sarebbe però una Diplotaxis muralis) o rucchetta o rughetta, secondo alcuni E. s. var vesicaria, mentre il secondo è la Diplotaxis erucoides (erucoide quindi che rassomiglia alla vera Eruca), oltre a Diplotaxis tenuifolia. Sono tutte specie appartenenti alla famiglia delle crucifere (i 4 petali del fiore sono disposti a croce; dal lat. tardo crucĭfer -ĕris ‘portatore di croce), sezione brassicacee, la stessa famiglia dei cavoli (verza, cappuccio, crauto, cavolini Bruxelles, ecc), del ravizzone, delle rape, dei ravanelli, del rafano, della colza, della senape (sia nera, erba medicamentosa rubefacente, cioè che arrossa la pelle, che bianca con cui si prepara la senape alimentare), ecc.
La rucola (sia quella coltivata che quella spontanea) sembra essere originaria dell’Asia occidentale (Persia, visto il notevole uso emerso dalle ricerche archeologiche), naturalizzata poi in altre aree asiatiche e in quelle mediterranee, grazie alle migrazioni dei popoli, ai commerci e alle guerre. Coltivata nel Medioevo, è stata poi abbandonata per il suo sapore ed odore penetranti e il timore di malesseri, per poi essere riscoperta dal secondo dopoguerra, riconoscendone la bontà. Oltre che nel classico orto, oggi la rucola si coltiva particolarmente in serra, con notevole grado di tecnologia, per avere un prodotto di quarta gamma (anche tipo germogli, da semi appena germogliati, come per la soia e altre specie), già pronto da mangiare, con redditività molto elevata per il coltivatore.
La specie Eruca (quella che compriamo al mercato), parola che in latino indica il “bruco” (probabilmente perché la pianta in natura e nell’orto è assalita da tanti insetti fitofagi, le cui forme larvali spesso sono bruchi), è coltivata praticamente in tutto il mondo, date le sue semplici esigenze per quanto riguarda clima, terreno e acqua, nonché per il suo breve ciclo di vita, trattandosi di pianta a ciclo annuale (per cui deve essere riseminata ogni anno), al contrario del tipo Diplotaxis tenuifolia che è pianta spontanea, perenne e vivace, nel senso che in inverno perde l’apparato fuori terra per riformarlo poi in primavera); D. erucoides è anche annuale ancorchè spontanea.
Eruca sativa può arrivare anche a 20 - 60 cm di altezza, i fusti sono ramificati, le foglie sono succose, lirate (cioè divise in lobi laterali che arrivano alla nervatura centrale) e pennato fesse (lobi disposti cime le barbe di una penna d’uccello), con lobi dentati o molto incisi, fiori di colore bianco giallastro o violacei, con vene porporine o violette. Il frutto è una siliqua (frutto secco deiscente) bruna, a sezione triangolare, ricurva e rostrata all’apice, contenete i semi. Diplotaxis erucoides, spontanea negli incolti, è molto simile alla precedente, ma con foglie più piccole, i fiori sono bianco rosati con venature violette. Ogni anno la pianta si riproduce per seme aprendo le silique. Quindi anche se non coltivata si riproduce per seme.
Esiste anche la Diplotaxis tenuifolia, simile alla rucola come la precedente, anch’essa con foglie più piccole, ma a ciclo poliennale (botanicamente perenne), per cui è vero che diffonde i semi, ma il medesimo cespo ogni anno non muore ma riforma in primavera la parte aerea. Esiste anche la Diplotaxis muralis, diffusa in Asia, Africa del Nord e Europa nei luoghi inospitali, le cui foglie ricordano molto la rucola e sono commestibili.
La rucola coltivata si distingue da quella selvatica perché ha foglie lunghe da 10 a 15 centimetri, meno dentellate di quelle della spontanea, più grandi e decisamente meno piccanti, per il minore contenuto di olio. Le due specie spontanee, possono raggiungere anche l’altezza di 100 cm, in funzione delle caratteristiche del luogo in cui vivono (concorrenza con altre erbe spontanee, tipo di terreno, piogge, salinità, vento, ecc.), hanno foglie in genere più piccanti della coltivata perché crescono in condizioni ambientali più difficili, tali da far produrre più principio piccante e far si che questo sia maggiormente concentrato.
A proposito della piccantezza va detto che i Romani (e gli altri poli del tempo) riconoscevano alla rucola molte proprietà salutari, ma in particolare di essere afrodisiaca. Ne facevano un uso notevole per le proprietà medicamentose (se ne fanno tisane serali rilassanti, specialmente in presenza di tosse convulsa), dimostrate prima dalla tradizione popolare e poi da recenti ricerche, quali: miglioramento delle funzioni epatiche, apporto notevole di calcio per le ossa, proprietà carminative (promuove l'espulsione dei gas dallo stomaco e dall'intestino) e diuretiche (capace di aumentare la secrezione dell'urina), immunoprotezione, tutto grazie alla composizione delle foglie che illustrerò a breve.
In Italia la rucola è coltivata specialmente nel Mezzogiorno, sia come erbaio per gli animali che per l’uso alimentare umano (come insalata e per alcune salse e liquori, come il rucolino della Campania, usato come digestivo). Dai semi di rucola si estrae olio (praticamente uguale a quello di senape), per uso medicamentoso e cosmetico, tanto che coltivazioni di rucola da olio si sono affermate sia in Asia che in Germania. Il contenuto in olio dei semi (piccolissimi, giallo scuro, è mediamente pari al 25-33%, mentre le sue caratteristiche sono simili a quelle dell’olio di ravizzone e il suo sapore acre può essere eliminato solo con la raffinazione. L'olio della pianta può essere utilizzato non solo come integratore alimentare, ma anche come uno dei componenti di maschere per viso e capelli fatte in casa, rinforzo delle unghie e crema nutriente per il corpo.
Coltivare nell’orto la rucola non comporta particolari difficoltà (infatti la ruchetta si trova praticamente sempre), perché teme essenzialmente gli eccessi di acqua, mentre non teme alcun tipo di terreno, anzi più arido e poco fertile è il terreno e più piccanti saranno le foglie. La rucola destinata a produrre seme (se ne ottiene circa 15 q per ettaro) si semina in primavera in file distanti 20 – 25 cm, distribuendo i semi nelle righe con una seminatrice manuale o meccanica seconda dell’ampiezza del terreno (si opera come per la colza), usando 10 – 12 kg di seme per ettaro.
Quando invece la rucola viene coltivata per ortaggio da foglia, la semina inizia a marzo in modo da avere foglie fresche da giugno in poi, proseguendo anche per i mesi successivi (diciamo fino alla fine dell’estate), intervenendo con piccole somministrazioni di acqua nei momenti più critici, specialmente allo spuntare delle pianticelle. Si fanno righe distanti 25 cm almeno, profonde 1,5 cm, i cui si pongono i semi a 2 – 3 cm uno dall’altro. Le piantine nate andranno diradate in modo che l’interspazio sia di 7 – 10 cm da una piantina all’altra. Non è il caso di concimare. Dopo circa un mese dalla semina potremo raccogliere le foglioline, tagliando la piantina alla base, lasciando una porzione del colletto di 5-7 cm in modo che il vegetale possa ricacciare e fare altre foglie. In questa coltivazione bisognerà eliminare gli steli fiorali, perché se la pianta va a fiore curerà la formazione del frutto (siliqua) e dei semi ivi contenuti, trascurando quasi del tutto la formazione delle foglie: le foglie raccolte da una rucola fiorita sono più coriacee, sgradevolmente piccanti e aromatiche. La rucola può essere coltivata con successo anche in vaso, rappresentando insieme a prezzemolo, basilico e menta la classica raccolta di erbe aromatiche sul balcone o terrazzo.
Dal punto di vista nutrizionale la rucola è davvero fonte di preziose sostanze, benefiche per l’organismo: 100 g di rucola non condita apportano appena 28-30 kcal, tanta acqua (90 g), pochi zuccheri (4 g), poche proteine (2,6g), pochissimi lipidi (0,5 g), un po’ di fibra (0,9 g), ma in compenso tanto calcio (310 mg), potassio (470 mg), fosforo (40 mg), magnesio (47 mg) ferro (5 mg), vitamina C (110 mg) e vitamina A (740 µg), vitamina K, vitamine del gruppo B, oltre a zeaxantina, carotene e luteina (tutti antiossidanti). Queste componenti giustificano l’uso anche medicinale ed erboristico della rucola. Inoltre la rucola contiene erucina (in sigla ER, contenente solfo e derivati dell’acido cianidrico), sostanza antiossidante che, inoltre, aiuta la vasodilatazione sanguigna e risultando perciò antiipertensiva, specialmente perché la rucola di solito si mangia cruda, pur miscelata con altre erbe.
In cucina la caratteristica principale della rucola (specialmente se spontanea) è la piccantezza delle foglie, dovuta alla presenza di isoticianati contenenti zolfo e gruppo cianidrico e originati dalla demolizione mirosinasica (cioè causata catalizzata dall’enzima tirosinasi – MYR) dei glucoinosilati – GLS che si verifica con la masticazione delle foglie (come accade nell’aglio, che se viene morso risulta piccantino in bocca, oltre che sgradevole), la quale è molto più elevata se la pianta è stata allevata in condizioni idriche difficili o addirittura raccolta negli incolti e in zone aride.
Le foglie della rucola risultano, come è noto, particolarmente aromatiche e piccanti, oltre che gradevolmente amarognole, e per queste caratteristiche si preferisce mangiarle in insalate in cui siano presenti altri vegetali. Va detto però che la rucola, specialmente se selvatica, contiene molto acido erucico, (che prende questo nome proprio perché contenuto nella rucola) come colza, senape, broccoli vari, per cui è preferibile moderare quantità e frequenza del suo consumo, considerato che, se eccessivo, causa danni al cuore. Questo composto è particolarmente presente nell’olio e nei semi delle piante citate, ma lo si ritrova anche nei tessuti (nei vacuoli della cellula) della pianta come le foglie, nelle quali avvengono i processi di fotosintesi e respirazione cellulare. Per poter fruire dei benefici dell’olio di rucola e degli altri elementi contenuti, è bene raccogliere le foglie poco prima di mangiarle; se ciò non è possibile teniamole in frigorifero per 2 – 3 giorni, avvolte in carta porosa, oppure in un sacchetto di carta forellato. Evitiamo il congelamento perché perderemmo completamente il prodotto per aver distrutto l’olio essenziale, cioè profumo e piccantezza, anche se l’avessimo prima sbollentato per un solo minuto.
Le foglie di rucola oltre che nelle classiche insalate pure o miste (alle quali dono forza e freschezza), possono impreziosire sughi, pizze, torte salate, panini, minestre, patate, pomodori, ravanelli, capperi, acciughe e addirittura la pasta, da preparare come una pasta con le rape (alla pugliese, con acciughe) o condita con legumi; ottimo anche il pesto a cui aggiungeremo pinoli, noci e ottimo olio evo.
Con la rucola però non bisogna esagerare, non solo per l’acido erucico, ma anche perché si verificano gastralgie, bruciori di stomaco e diarrea. Inoltre, essendo ricca di vitamina K, coagulante, è bene che non esageri chi assume farmaci anticoagulanti (tipo cardioaspirina), in quanto gli effetti sarebbero contrastanti; attenzione anche per chi soffre di calcoli, visto l’alto contenuto di calcio, e di insufficienza renale, dato l’alto contenuto degli altri minerali.
Resta comunque innegabile che mangiare una qualsiasi preparazione con la rucola rende il piatto più vivace e appetibile. Un consiglio per il vino da abbinare a rucola pura o presente in modo rilevante: ci troviamo di fronte a una componente con tendenza amarognola, aromaticità e piccantezza avvertibile anche se non eccessiva, per cui opteremo per vini (bianchi, rosati o rossi che siano) giovani, morbidi, profumati e con buona persistenza aromatica. Se la piccantezza è eccessiva opteremo per la semplice acqua, specialmente se vi è presenza di aceto nel condimento.
Note bibliografiche
- Cappelletti, Botanica sistematica, Ed. UTET
- AA.VV., Enciclopedia Agraria, Ed. UTET
- AA.VV., Il buon sapore dell’orto, Edagricole
- Malerba – Leni, Erbe spontanee in tavola, Ed. Sonda
- Dadduzio-Mininni-Renna, Erbe spontanee, Ed. Gribaudo
- AA.VV., Tecnica dell’abbinamento cibo vino, Ed. AIS
Photo by Sara Albano








































































































































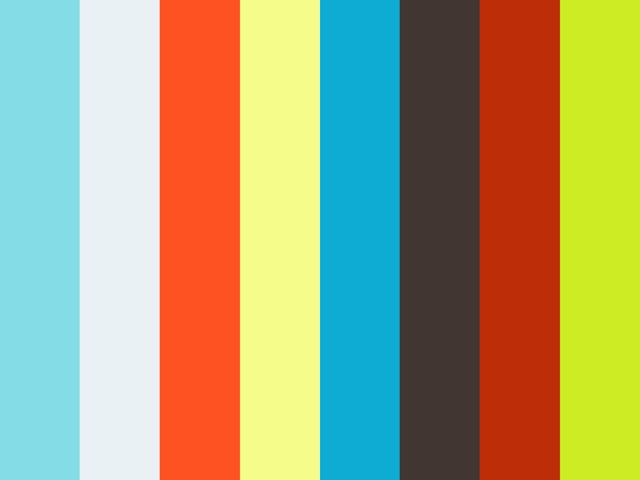
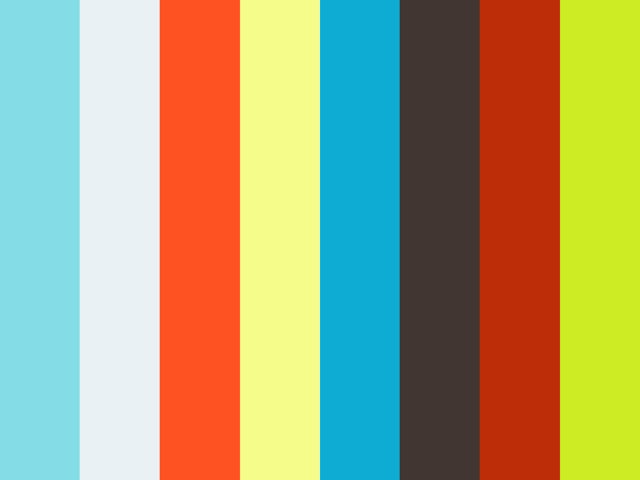
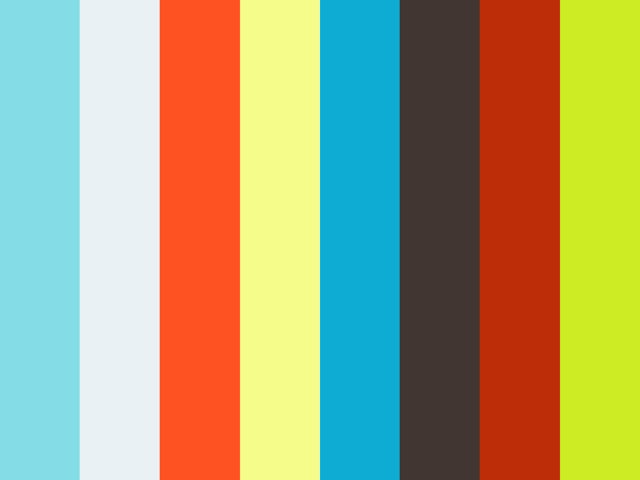
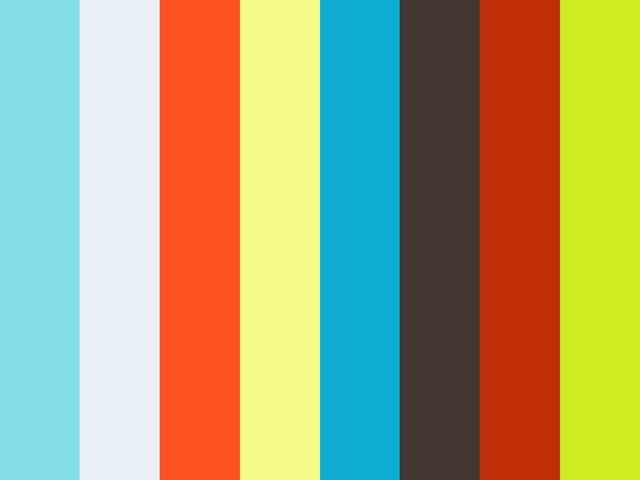
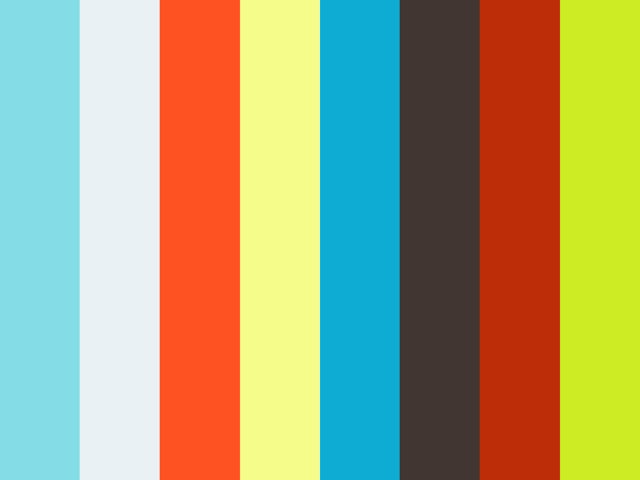
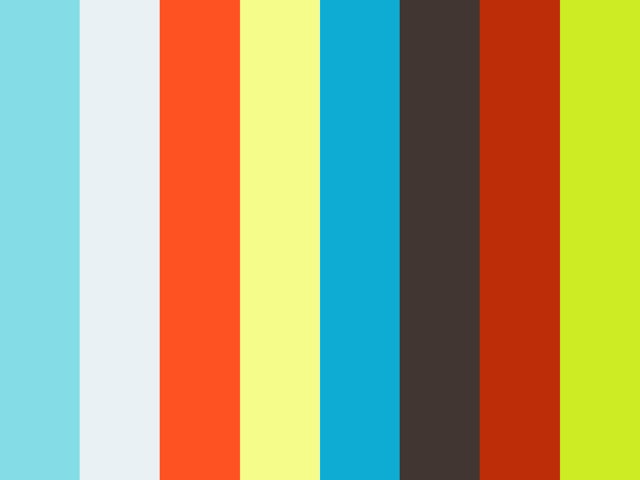

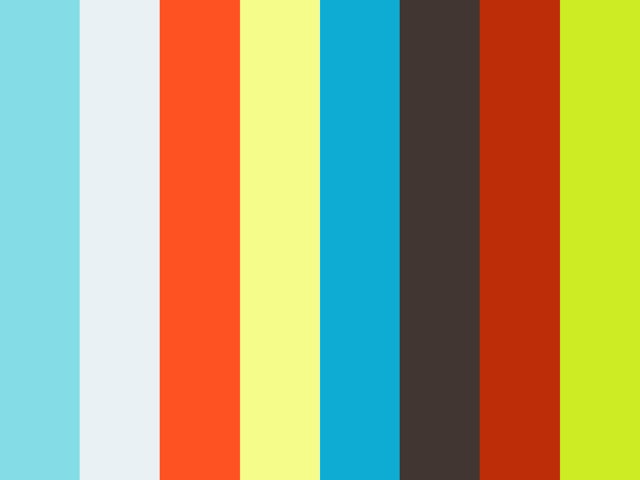

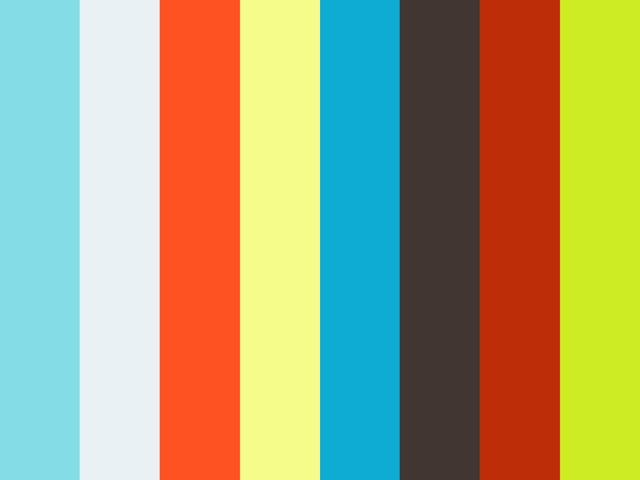
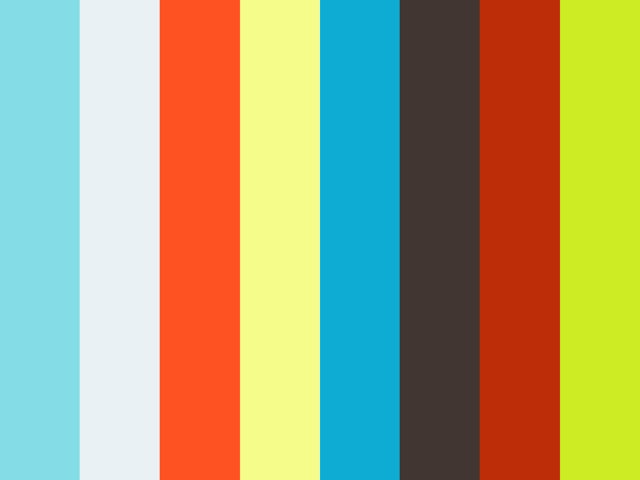
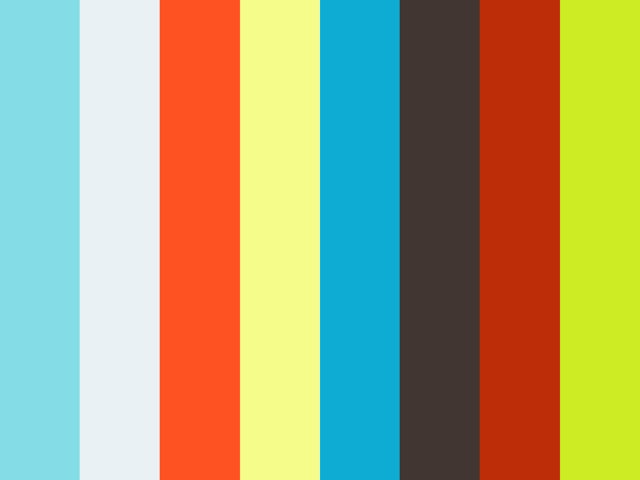
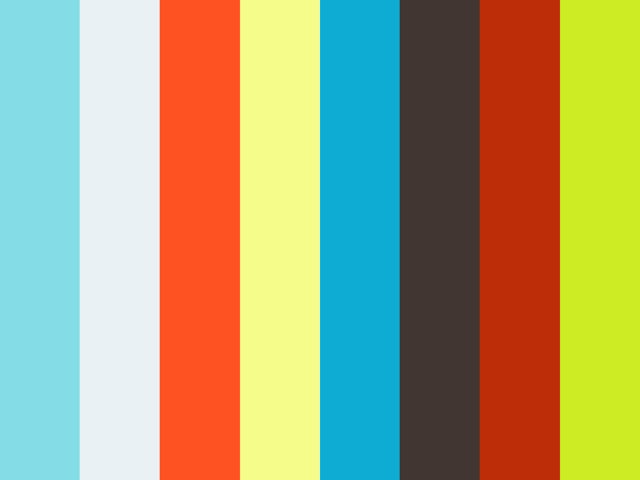
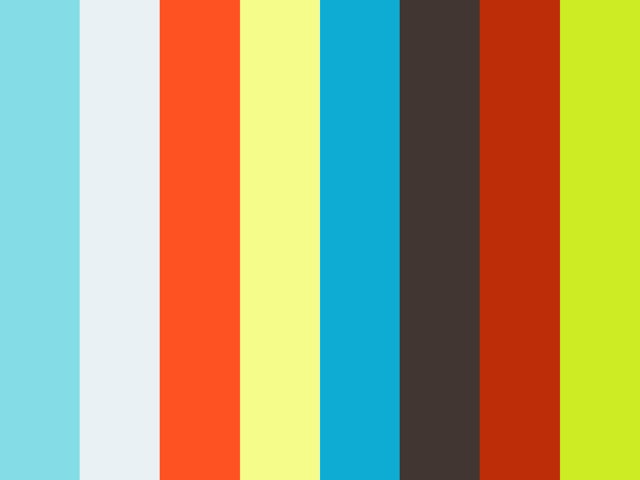
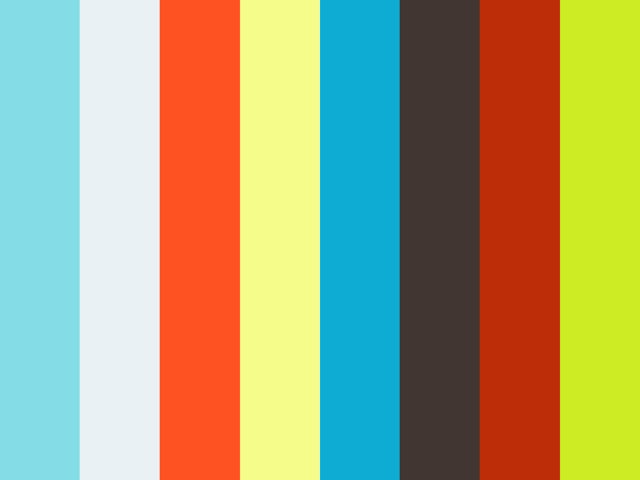
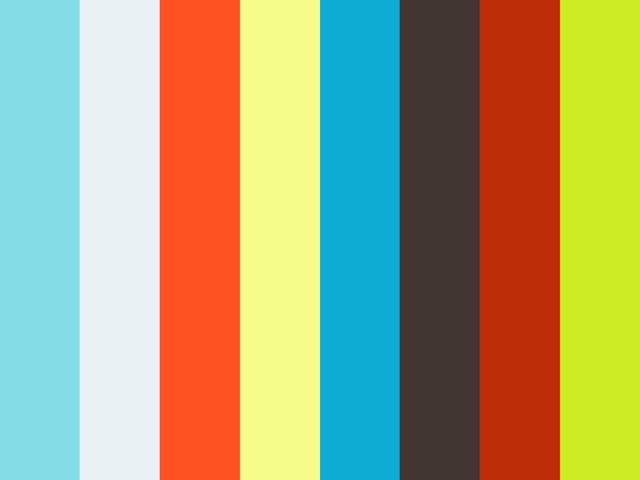
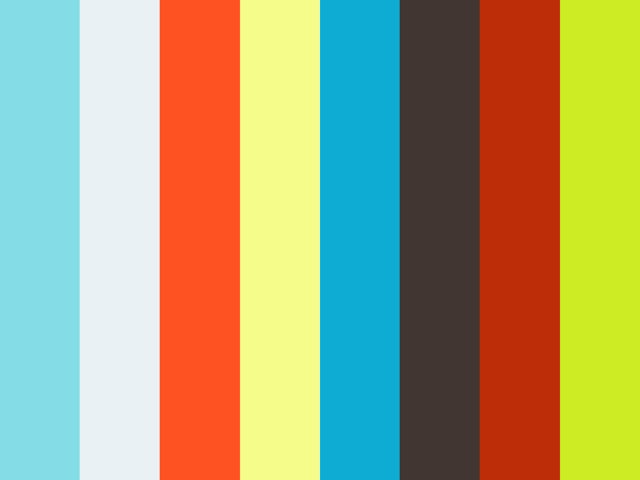





0 Commenti