Questo è il dilemma: ma quali sono le differenze tra i due processi?
Origini, storia, curiosità e proprietà dell’agrume più amato tutto l’anno: ecco tutto ciò che non sapevate sul limone

Uno degli spettacoli più belli che la vita mia ha riservato, è stato quello offertomi, alcuni anni fa, da un esteso limoneto in frutto. Auguro a tutti di poter vivere la stessa esperienza, tanto è bello il quadro colorato di verde (le foglie), giallo (i limoni) e color nocciola (il tronco) offerto dalle piante, un abbinamento che madre natura offre e che sembra non aver richiesto alcun impegno, mentre in realtà piante e ambiente hanno operato precise scelte biochimiche e morfologiche.
Un quadro capace di infondere gioia per i bei colori, insieme a stupore, bellezza, calma e serenità che il tutto infonde nell’animo, dovuta certamente anche all’insita cromoterapia e aromaterapia di questi agrumi. Basterebbe già questo ineguagliabile quadro naturale per definire il limone “grandioso elemento naturale”, che all’uomo non può che giovare. Se a ciò aggiungiamo le proprietà dei limoni quanto a buccia, polpa e semi, allora l’insieme diventa magnifico, quasi divino!
Strano ma vero: gli antichi Romani non conoscevano il limone! Infatti nessun botanico e naturalista dell’epoca ne parla nelle proprie opere, tanto meno i cuochi e gli organizzatori banchetti (molti però non sono d’accordo per via di alcuni dipinti degli scavi di Pompei; sembra però che gli agrumi raffigurati non siano limoni altri agrumi). A sostegno della prima tesi si afferma che nelle ricette i Romani usavano aceto e non limoni per acidificare e conservare cibi e preparazioni, come il garum. La prima tesi è sostenuta anche dal fatto che furono gli arabi a descrivere la pianta e il suo frutto nel X e XII secolo (portato poi in Sicilia dopo la conquista), dopo che il limone si era già diffuso nel 700 d.C. in Iraq, Egitto e Persia, tanto che secondo alcuni ricercatori il termine limone deriverebbe dal persiano limu, termine riferito però a tutti gli agrumi.
Originario, come tutti gli agrumi, della Cina e aree circostanti (specialmente in India e Birmania), il limone in Europa fu coltivato inizialmente in quel di Genova, e fu proprio da questa città che Colombo portò piante e frutti in America, per finire poi nel XIX secolo in Florida e California. Attualmente i maggiori produttori di limoni sono India (3.150.000 t), Messico, Cina Argentina, seguiti a distanza da U.S.A. e Italia (380.000 t; 12.600 ha; il 90% della superfice in Sicilia; il 42% della superficie nazionale è in Siracusa;). Il limone (botanicamente Citrus limon, famiglia delle Rutacee (nome che deriva dalla specie più rappresentativa Ruta graveolens), nome che indica non solo la pianta ma anche il frutto, è pianta molto sensibile al freddo, caratteristica che spiega la diffusione della coltivazione lungo la costa jonica e quella tirrenica della Sicilia e della Calabria, oltre che nella penisola sorrentina e amalfitana, limitatamente però a circoscritti ambienti pedoclimatici. La specie secondo alcuni studiosi sarebbe in realtà un ibrido naturale tra arancio amaro (Citrus aurantium) e cedro (Citrus medica). In Italia la coltivazione del limone interessa Sicilia, Calabria e Campania; al nord solo sul lago di Garda.
La specie è spesso rifiorente, con fioritura che, a seconda delle condizioni pedoclimatiche zonali e della varietà, può verificarsi da marzo a giugno (prima fioritura) producendo quelli che si indicano con il nome limoni (comprendenti i primofiore ammarsanati, i primofiore, i limoni e i limoni biancuzzati), da giugno ai primi di agosto (seconda fioritura) producendo i cosiddetti bianchetti (comprendenti i biancuzzi o bianchetti) e dalla seconda metà di agosto a ottobre (terza fioritura), con la produzione di verdelli (distinti in maggiolini, agostari e bastardi), frutti nettamente differenti per caratteristiche morfologiche e qualitative; la cv Lunario fiorisce tutto l’anno, producendo frutti continuamente (limone di ogni mese).
La prima fioritura per le piante non rifiorenti (come la cv Interdonato) rappresenta la quasi totalità della produzione annuale, con limoni che si raccolgono tra metà settembre dello stesso anno (primofiore) e maggio dell’anno successivo (limoni biancuzzati). La seconda fioritura caratteristica delle cv molto rifiorenti (come il Femminello comune, il Femminello sirausano, il Femminello S. Teresa, il Femminello Continella e altri) non fornisce frutti di pregio, e la raccolta si fa da febbraio a maggio (bianchetti). La terza fioritura si verifica di solito solo nelle piante soggette a forzatura, mentre quella spontanea è piuttosto rara a verificarsi; i limoni derivanti si raccolgono dalla fine di aprile (limoni maggiolini) fino a settembre (verdelli agostari o bastardi), molto apprezzati dai mercati.
La forzatura è una tecnica agronomica consistente nella interruzione dell’irrigazione delle piante (30-40 giorni al massimo, per non compromettere la produzione dell’anno e successive), praticata in genere a fine giugno, per riprenderla poi ad agosto previa abbondante concimazione. In questo modo si sottopone la pianta a stress idrico, con perdita dei frutticini presenti e avvizzimento delle foglie; la pianta anticiperà la fioritura e la produzione dei verdelli o limoni d’estate. I verdelli sono chiamati così per il colore verde della buccia, hanno succo meno acidulo rispetto al primofiore (dalla prima fioritura) e al bianchetto (dalla seconda fioritura); peraltro maturano in piena estate quando la richiesta di limoni è massima. Non tutte le cv si possono sottoporre a forzatura.
Per quanto riguarda le cultivar si può affermare che in Italia ogni zona limonicola ha le sue, di solito originatesi per mutazioni gemmarie spontanee, trasmissibili alla discendenza per moltiplicazione (procedimento asessuato), difficilmente per riproduzione (procedimento sessuato). Esempi classici di mutazione gemmaria sono il limone Femminello e il Lunario; in altri ambienti, invece, le cv diffuse derivano da ibridazione spontanea tra agrumi, sono stabili e produttive solo in quell’ambiente, come accaduto per la cv Interdonato. Per quanto riguarda la produttività la cv superiore a tutti é la Femminello siracusano, mentre quasi sempre presente nelle diverse cv è la sensibilità ad una malattia fungina molto grave, chiamata malsecco degli agrumi, molto temuta per il Femminello comune.
La cultivar più diffusa ed apprezzata in Italia è il Femminello comune, molto produttiva e di grande qualità, buona rifiorenza (solo se sottoposta a forzatura); molto diffusa è anche la cv Lunario, a fioritura quasi continua, a rifioritura spontanea, abbastanza resistente al malsecco; ha però il difetto di una produttività inferiore a quella del Femminello comune, con frutti meno ricchi di acido citrico, oltre alla forma del frutto non apprezzata dai mercati; la sua produzione annuale, per quanto presente ogni mese, non uguaglia quella del Femminello comune. Altre cv di limone coltivate in Italia sono la Interdonato, la Monachello, la Arancino, vari tipi di Femminello, e altre minori di valenza solo locale e amatoriale.
Particolarmente apprezzate sono le cv Limone ovale di Sorrento o di Massalubrense (diffuso in tutta la penisola sorrentina, a Castellammare di Stabia, Pomperi e Torre Annunziata), il Limone di Procida (coltivato nella zona omonima, tipico per la pezzatura che arriva anche a 1kg e la bassa acidità, tanto che lo si consuma direttamente, specialmente in insalata) e lo Sfusato amalfitano o Limone di Amalfi. Tra le cv di limone coltivate all’estero sono da ricordare l’Eureka molto diffusa negli U.S.A., principalmente in California e Arizona, oltre che in Argentina e Cile, Sud Africa, Australia, insieme alle cv Lisbon, Genoa e Villafranca.
Dal punto di vista nutrizionale il limone ha una composizione interessante non tanto in termini di nutrienti (proteine, grassi, zuccheri), quanto per la presenza di microelementi ed altri composti capaci di agire sul metabolismo umano come integratori e catalizzatori delle reazioni redox cellulari. La composizione di 100 g di limone quale frutto, contemplano una parte edibile di 64 g, un apporto calorico di appena 15 kcal, 89,5 g di acqua, 0,6 g di proteine, 2,3 g di zuccheri (contrariamente a quanto si crede, la presenza degli zuccheri è dimostrata dal fatto che le dita diventano appiccicose dopo aver maneggiato il limone), 1,9 g di fibra solubile; notevole la presenza di minerali come calcio (14 mg), potassio (140 mg), magnesio (12 mg), cloro (5 mg), solfo (12 mg), oltre a tracce di ferro, sodio, zinco, selenio e manganese; quanto a vitamine ritroviamo in primis vitamina C (50 mg), niacina (vit. PP 0,3 mg), folati (sali dell’acido folico o vit. M o B9), vit. B6 (piridossina 0,11 mg), acido pantotenico (vit. B5 0,23 mg), vit. B1 (tiamina), B2 (riboflavina), vit. B12 (cobalamina). Notevole è il contenuto in ac. citrico (50-80 g/l, responsabile del sapore più o meno aspro) e acidi malico (dal sapore erbaceo e pungente).
Coltivato inizialmente come pianta ornamentale, il limone ha registrato certamente i suoi primi successi come pianta medicamentosa. Il succo veniva usato come disinfettante (contro i batteri in particolare, ma in genere contro microrganismi grazie alla presenza di acidi, che comunque non sono però del tipo forte, per cui la loro azione è blanda), antiemorragico, antidiarroico, astringente, ipoglicemizzante, utile per contrastare l’aumento del colesterolo. La medicina popolare ha sempre usato il limone anche per ridurre la pressione arteriosa,asportare calli e verruche, curare grazie alla vitamina C malattie della pelle (come lo scorbuto) e dell’apparato respiratorio. Famoso l’uso di acqua calda e limone per favorire la digestione e la vita del microbiota intestinale, oltre che per la funzione epatica. La digestione viene regolata delicatamente e inoltre può aiutare sia in caso di costipazione che di diarrea. Il succo di limone fornisce molto acido citrico, che previene la formazione di calcoli renali e biliari.
Nel limone (frutto) la buccia ha in media un peso rilevante sul totale (può arrivare al 40%), aspetto che consente di sfruttare questo agrume sia come buccia che come polpa. Dalla buccia si estrae l’olio essenziale (per produrlo si usano limoni verdi, perché ne contengono di più di quelli maturi e gialli), di un bel colore verde – giallo, tipico per avere lo stesso profumo della buccia strofinata, ricco di limonene (un idrocarburo volatile, incolore a temperatura ambiente, con profumo tipico di arancia, anche se è la buccia di limone ad avere il maggior contenuto, da cui il nome attribuito) e pineni (isomeri α, β e γ, presenti anche nella resina di conifere, specialmente Pino).
L’olio essenziale di limone viene usato dall’industria alimentare come aromatizzante (Reg UE 1334/2008), oltre che in quella profumiera, mentre i residui (anch’essi profumati) finiscono nei detersivi cosiddetti “al limone”, ai quali conferiscono solo profumo senza incrementare il potere detergente. La buccia del limone è sfruttata anche per ottenere le pectine, oltre a trasformarle in prelibati canditi. Sempre usando la buccia si prepara il famosissimo limoncello, mentre dai semi si estrae olio, ricavando degli scarti destinati all’alimentazione animale.
Ma senza dubbio la parte più nota del limone è il suo succo, il cui peso giunge anche al 50% di quello del frutto intero, e che è usato in cucina per aromatizzare creme e dolci, per marinare/condire carni e pesci, condire insalate, condire riso, risotto e pasta, usare al posto dell’aceto, preparare la marmellata di limone o aggiungere ad altre confetture per schiarire il colore finale troppo bruno, evitare l’imbrunimento enzimatico della frutta tagliata per la macedonia, aromatizzare olio, a cui aggiungere un uso domestico come detergente profumato; mentre nell’industria per produrre limonata (con aggiunta di acqua e zucchero) o succo puro (pastorizzato si conserva, senza aggiunta d’altro, anche per un anno intero). Limonate e sorbetti al limone son elementi tipici dell’uso culinario del limone, ma tutto il frutto trova impiego in moltissime ricette (, sempre però a fini aromatizzanti e acidificanti.
Importante è il momento dell’acquisto: cerchiamo di scegliere (anche se in rete) limoni sodi e pesanti, indice di freschezza e ricchezza di succo, con buccia di colore uniforme. Per fare delle spremute o limonate sceglieremo frutti con buccia liscia e sottile, in modo che il maggior peso sia quello del succo. In Italia 6 limoni hanno ottenuto il riconoscimento IGP: “Il Limone di Siracusa”, “Il Limone Interdonato di Messina”, il “Limone Femminello del Gargano”, il “Limone Costa d’Amalfi”, il “Limone di Sorrento” e recentemente il “Limone di Rocca Imperiale”; nel resto della UE “Citricos Valencianos” per la Spagna e “Citrinos do Algarve” per il Portogallo.
Note bibliografiche
- P.Spina e altri, Trattato di agrumicoltura, Edagricole
- A. Colombo, Coltivare gli agrumi in piena terra e in vaso, Ed. Demetra
- S. Oberhammer, Depurati con acqua e limone, Ed. Mondadori
- Bonciarelli, Coltivazioni arboree, Edagricole








































































































































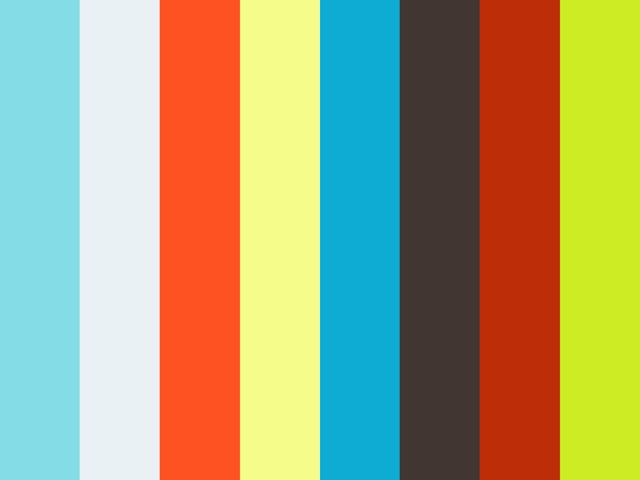
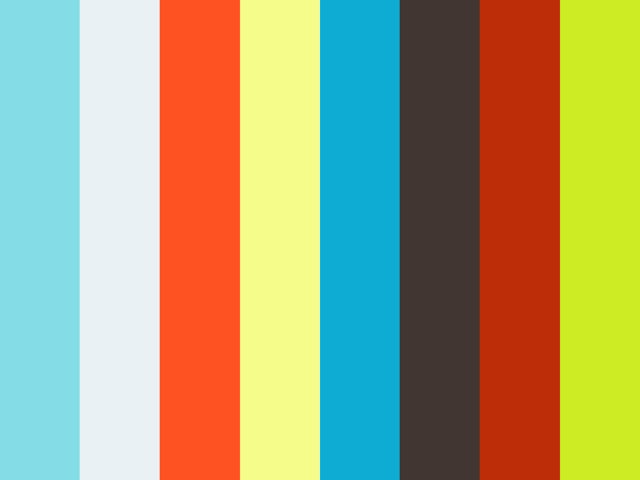
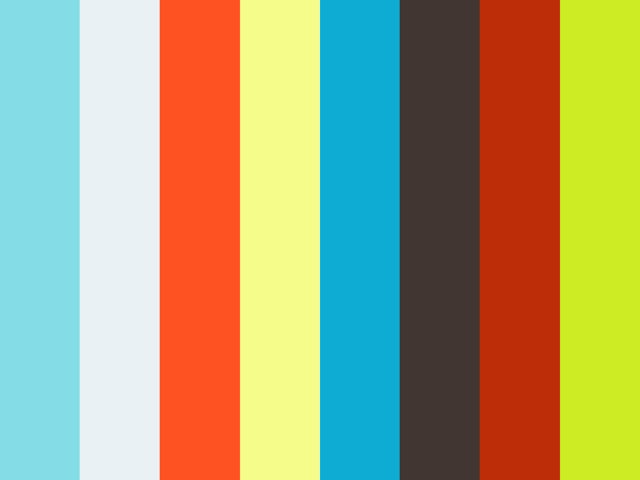
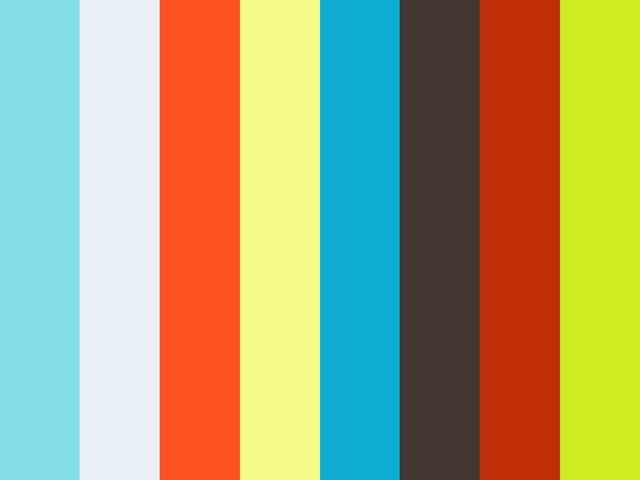
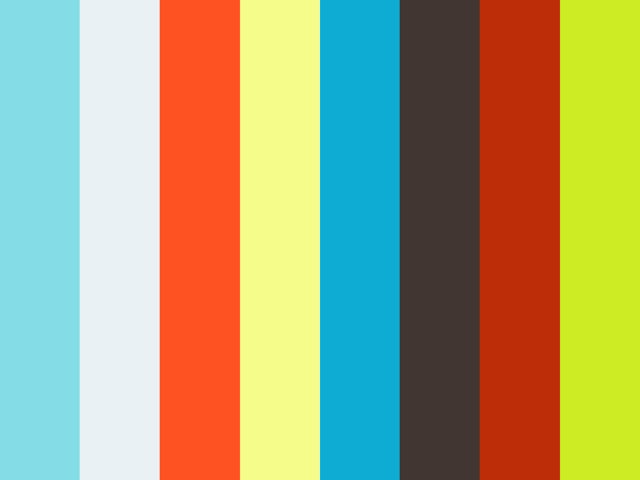
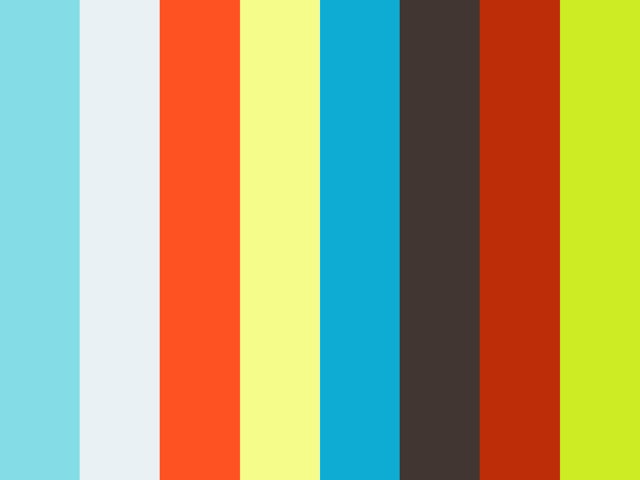

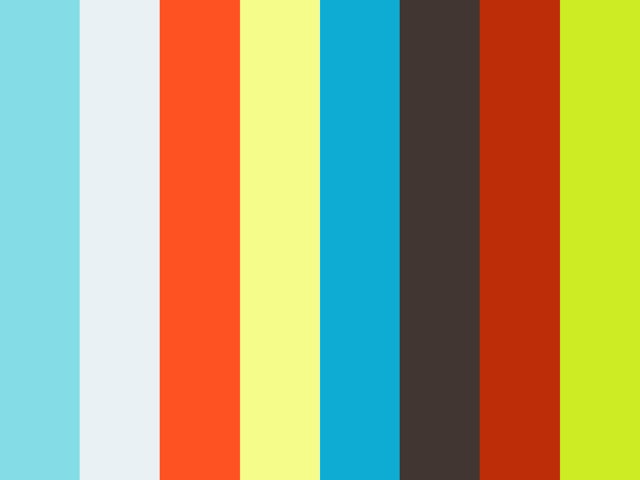

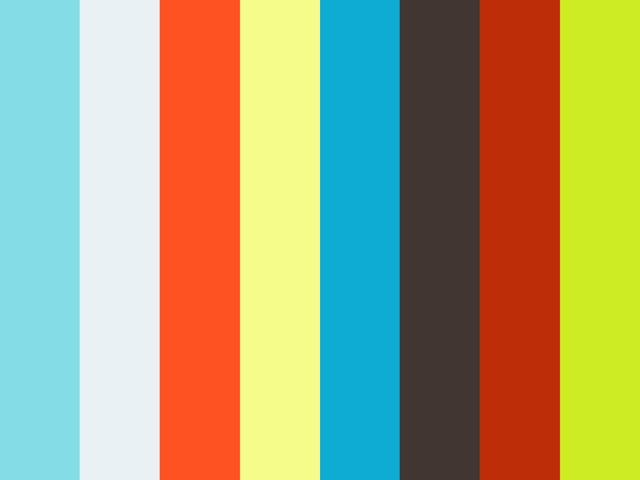
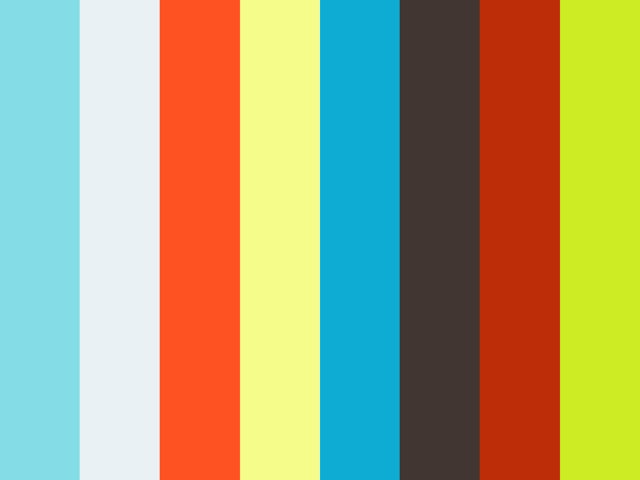
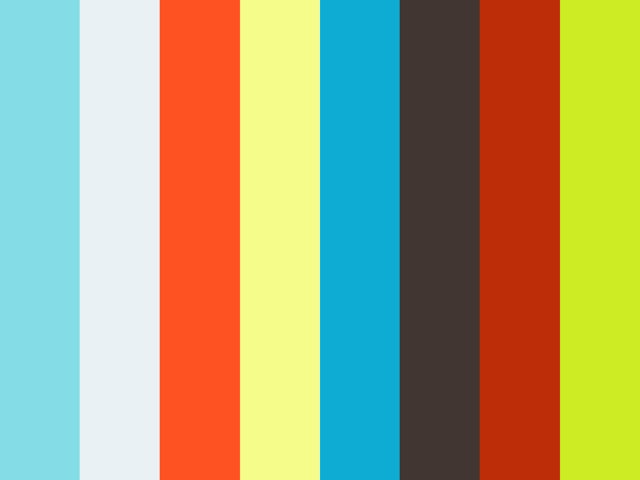
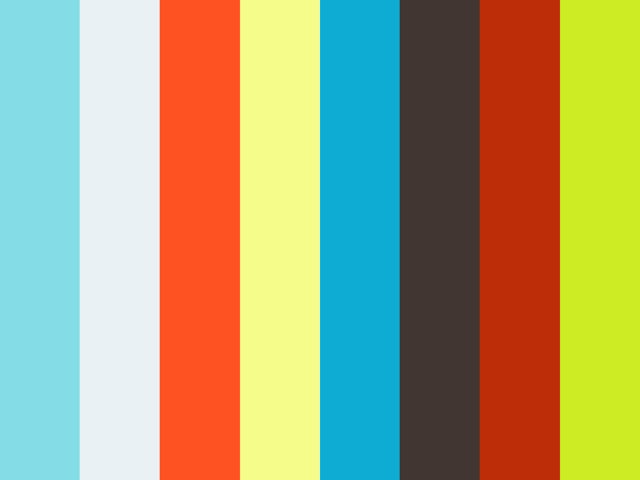
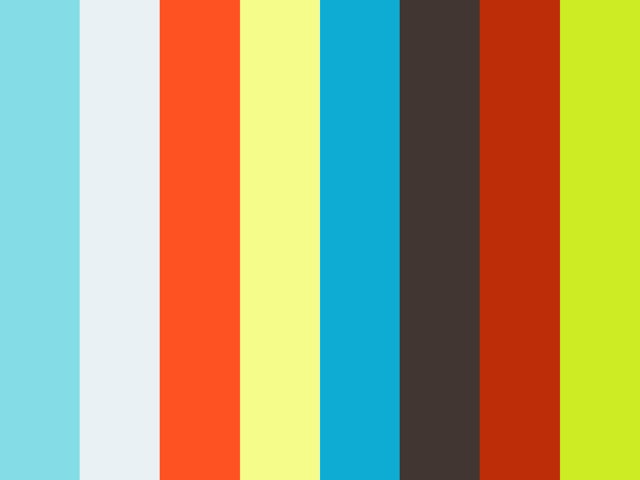
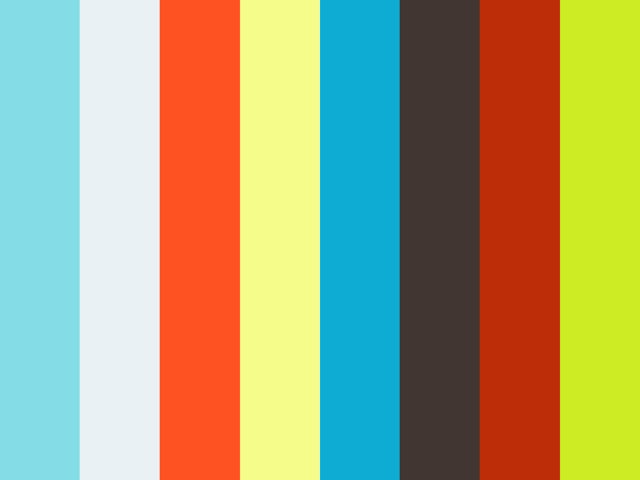
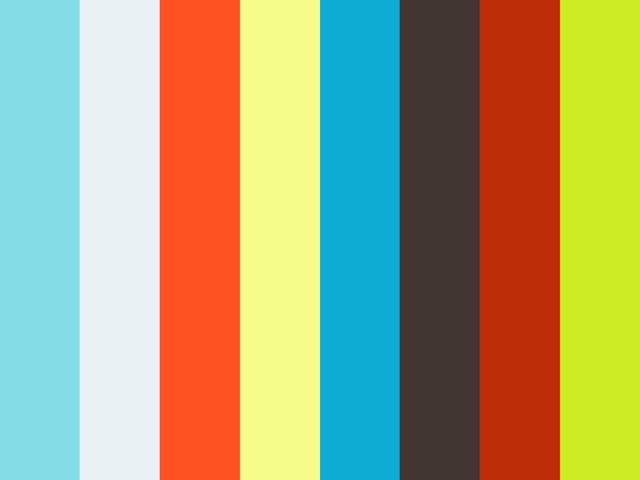
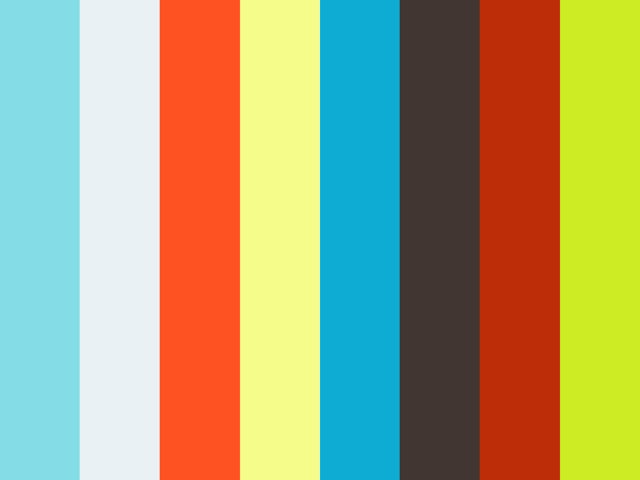





0 Commenti