Il decollo italiano del food delivery
PFAS: solo 4 lettere per indicare alcuni tra i responsabili moderni della contaminazione di falde acquifere, terreni e alimenti

PFAS: solo 4 lettere per indicare alcuni tra i responsabili moderni della contaminazione di falde acquifere, terreni e alimenti che sono pericolosi per l’ambiente e la salute dell’uomo. Le sostanze perfluoroalchiliche o acidi perfluoroacrilici sono una famiglia di composti chimici usati prevalentemente in campo industriale; sono tecnicamente catene alchiliche idrofobiche fluorurate che, tradotte in parole semplici, sono acidi particolarmente forti usati in forma liquida, con una struttura chimica che conferisce loro una particolare stabilità termica e li rende resistenti ai principali processi naturali di degradazione (fotolisi, idrolisi, degradazione biotica aerobica e anaerobica).
Dagli anni Cinquanta del secolo scorso (gli anni del boom economico e dell’industrializzazione di massa), i PFAS sono usati nella filiera di concia delle pelli, nel trattamento di tessuti, nella produzione di carta e cartone per uso alimentare, per i rivestimenti delle padelle antiaderenti e di contenitori per alimenti, nella produzione di abbigliamento tecnico impermeabile (con caratteristiche oleo e idro-repellenti), nelle schiume antincendio, negli insetticidi, nelle vernici, nei detersivi e nelle cere per pavimenti.
Le classi di PFAS più diffuse sono il PFOA (acido perfluoroottanoico) e il PFOS (perfluorottanosulfonato), caratterizzate da una lunga catena di carbonio (da 6 a 16 atomi di carbonio) che ne determina una prolungata persistenza nell’ambiente (maggiore anche ai cinque anni), al contrario di altre tipologie di PFAS a catena di carbonio corta (4-6 atomi di carbonio) che presentano una resistenza nell’ambiente più breve, misurabile in qualche decina di giorni.
E’ negli ultimi anni che gli effetti di queste sostanze sulla salute dell’uomo e in generale del pianeta sono oggetto di indagine e di continui monitoraggi: al momento, infatti, le analisi e gli studi medici e tecnico-scientifici li considerano tra i maggiori fattori di rischio per una ampia serie di patologie cliniche. Le ricerche hanno messo in evidenza che i PFAS sono sostanze cancerogene e che svolgono una funzione importante soprattutto sul sistema endocrino umano, compromettendo la crescita e la fertilità. Il loro ruolo è subdolo in quanto le conseguenze non hanno effetti immediati ma è la prolungata esposizione alle sostanze che può determinare l’insorgenza di patologie cancerose a carico di diversi apparati (tumori a reni e testicoli, sviluppo di malattie tiroidee, ipertensione gravidica, coliti ulcerose, addirittura malattie fetali e gestazionali).
La contaminazione dell’ambiente e di tutti gli organismi viventi avviene ad ampio raggio nello spazio e nel tempo ad opera soprattutto dello smaltimento illegale o non corretto dei rifiuti e degli scarti industriali che, non monitorati e controllati, penetrano facilmente nelle falde acquifere e, attraverso l’acqua, raggiungono i campi, i prodotti agricoli e perciò gli alimenti che l’uomo consuma oltre a disperdersi nell’aria come polveri.
Alte concentrazioni di PFAS sono tossiche sia per l’uomo che per tutti gli organismi viventi: queste sostanze, infatti, tendono ad accumularsi attraverso processi di bioamplificazione. Tali processi riguardano la catena alimentare e avvengono quando gli organismi ai vertici della piramide ingeriscono quantità di inquinanti superiori a quelle già diffuse nell’ambiente; l’acqua in questo senso è un vettore di trasmissione e assorbimento degli inquinanti. Considerando che l’esposizione dell’uso ai PFAS avviene principalmente per via alimentare, dobbiamo considerare che i cibi possono essere contaminati dai terreni o dalle acque usate per coltivarli, le carni possono risentire delle concentrazioni di pfas contenuti nei mangimi, in generale imballaggi e strumenti per la lavorazione e conservazione del cibo possono contenere e trasferire pfas.
Secondo l’EFSA (Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare), se nell’esposizione ai PFAS si considera l’effetto tempo è chiaro che i più a rischio sono i neonati e i bambini. Per questo è stata stabilita una nuova soglia di sicurezza tollerabile alla settimana pari a 4,4 nanogrammi per chilogrammo di peso corporeo. L’uso estensivo di questi composti, combinato con la loro persistenza, produce un vasto inquinamento ambientale tale da rilevarne la presenza in concentrazioni significative e non più sostenibili sia nel suolo che negli organismi viventi, uomo compreso.
Per questo, in campo normativo si sta lavorando per adottare nuovi orientamenti volti alla tutela collettiva della salute umana e ambientale; per gli alimenti, nello specifico, l’UE pone limiti più severi. Con un comunicato del 7 dicembre 2022, Stella Kyriakides, Commissaria per la Salute e la sicurezza alimentare europea, ha dichiarato: “Compiamo oggi un ulteriore passo avanti nell’aumentare il livello di sicurezza alimentare nell'UE e nel migliorare la protezione dei cittadini dalle sostanze chimiche nocive. Le nuove norme dimostrano il nostro impegno a mettere al primo posto la salute dei cittadini. Si tratta di una priorità ferma e costante”.
Dal 1 gennaio 2023 l’Unione adotta infatti nuove norme e limita il livello di quattro PFAS negli alimenti: l'acido perfluorottano sulfonato (PFOS), l'acido perfluoroottanoico (PFOA), l'acido perfluorononanoico (PFNA) e l'acido perfluoroesano sulfonico (PFHxS), note purtroppo per essere "sostanze chimiche eterne" (forever chemicals , in quanto la loro composizione non ne consente la degradazione. L’adozione di queste misure, basata sulle valutazioni scientifiche dell’EFSA, sono state accolte all’unanimità dagli Stati membri e rispecchiamo l’impegno assunto nell’ambito della strategia dell’UE in materia di sostanze chimiche sostenibili per contrastare la presenza di PFAS.
Photo via Pixabay
Scritto da Viviana Di Salvo
Laureata in lettere con indirizzo storico geografico, affina la sua passione per il territorio e la cultura attraverso l’esperienza come autrice televisiva (Rai e TV2000). Successivamente “prestata” anche al settore della tutela e promozione della salute (collabora con il Ministero della Salute dal 2013), coltiva la passione per la cultura gastronomica, le tradizioni e il buon cibo con un occhio sempre attento al territorio e alle sue specificità antropologiche e ambientali.





































































































































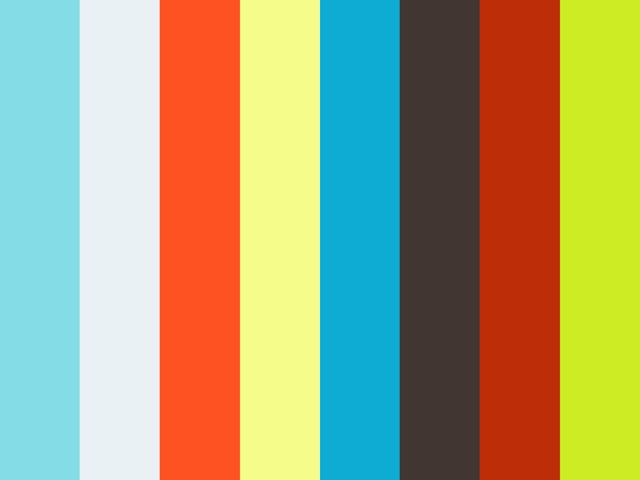
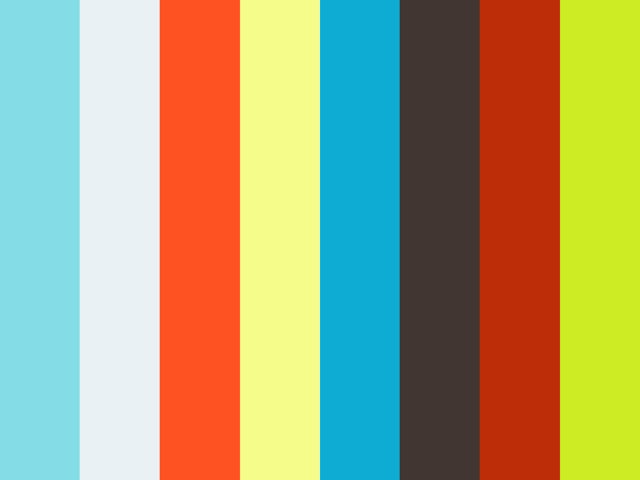
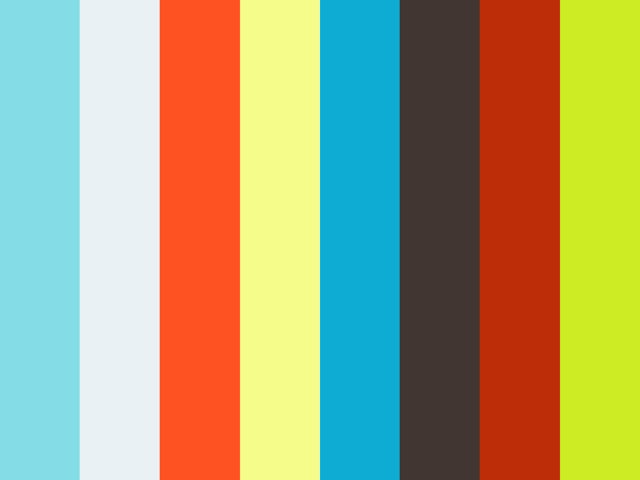
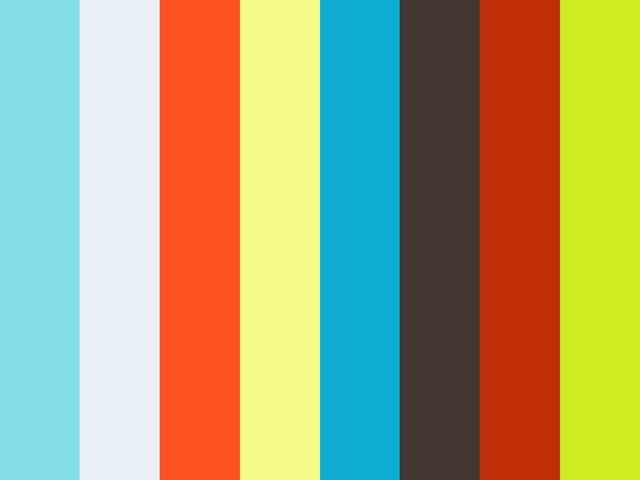
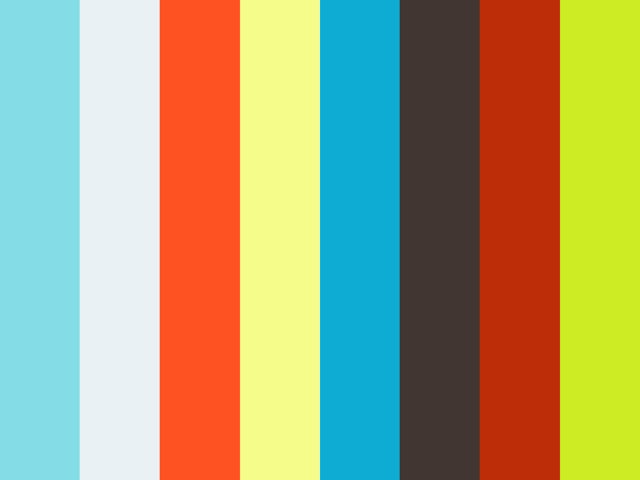
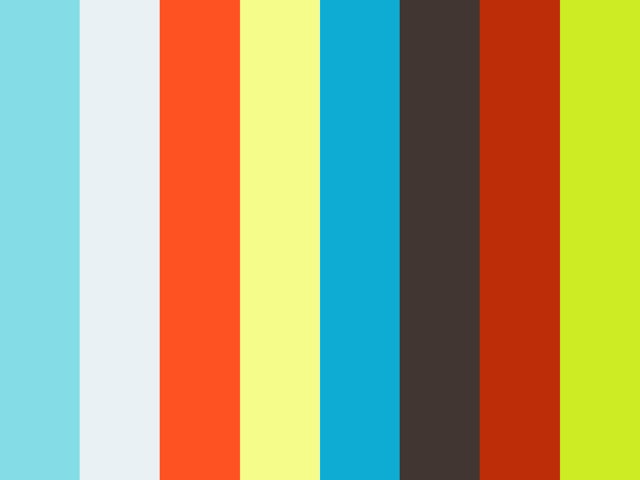

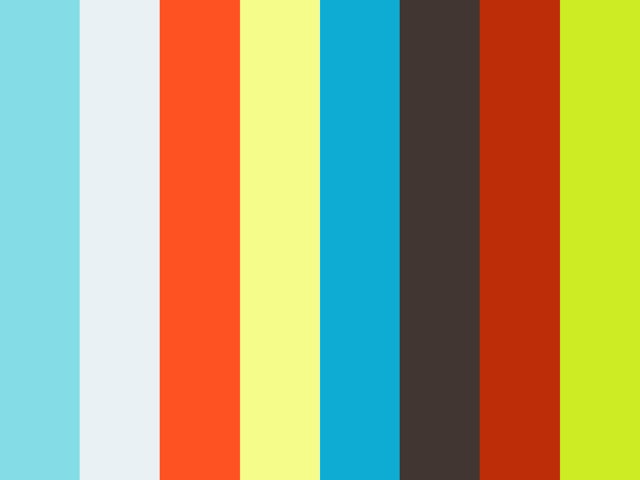

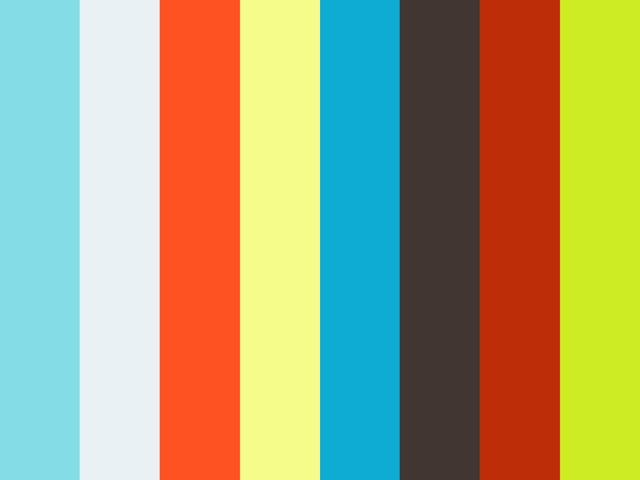
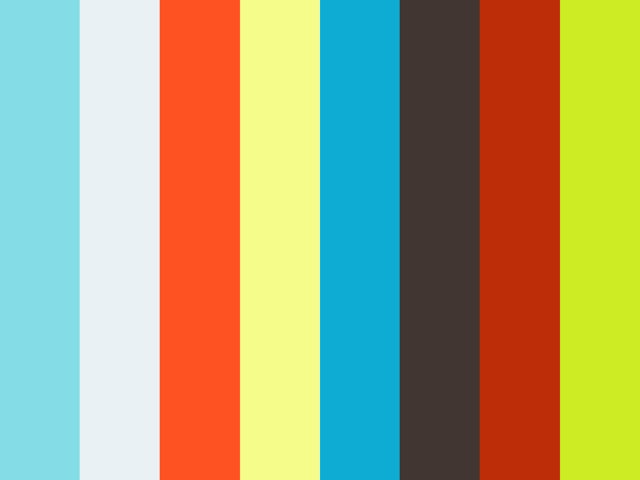
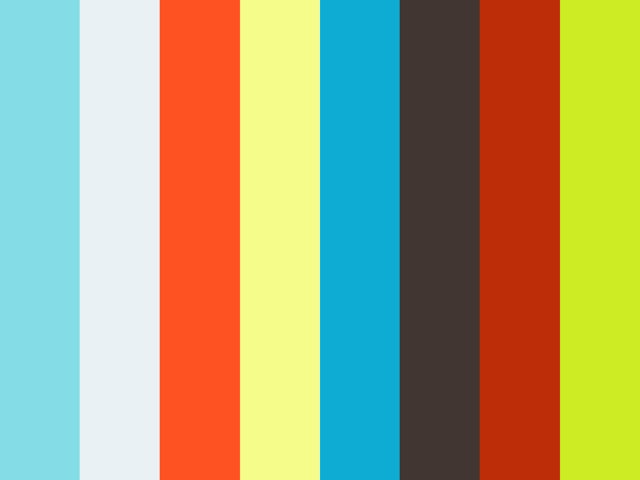
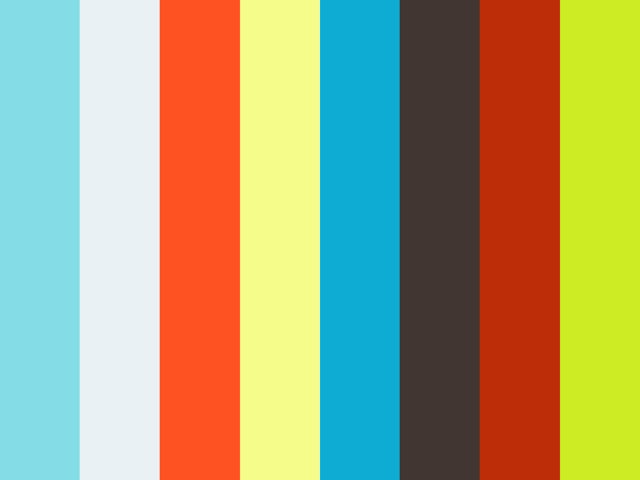
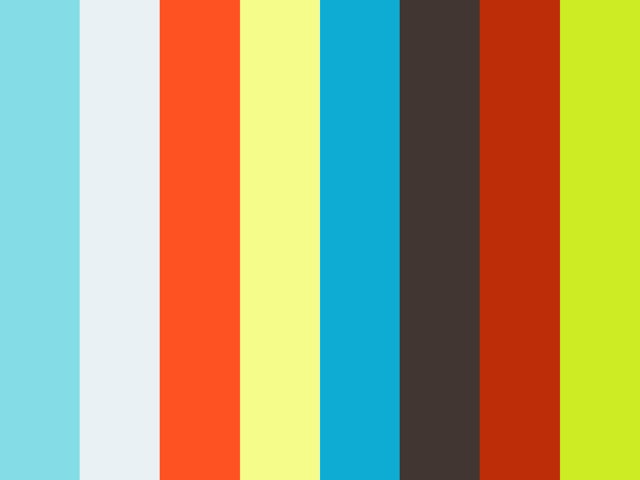
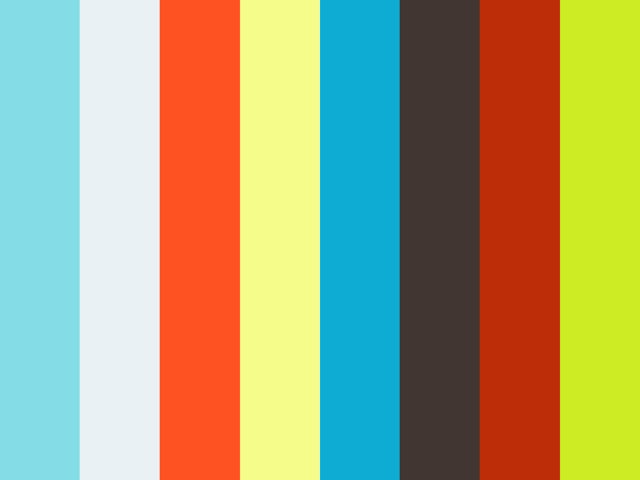
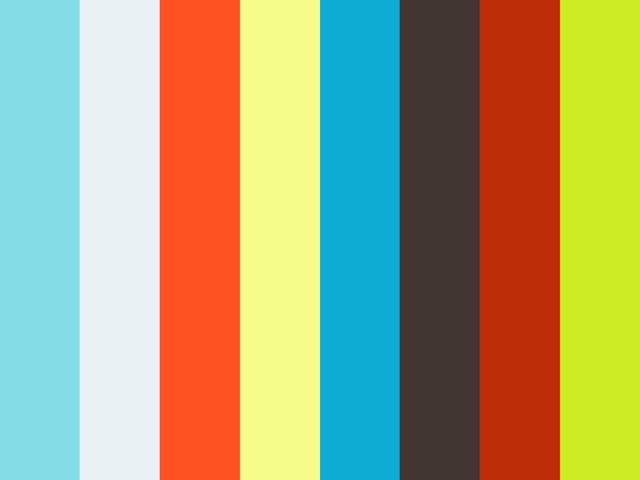
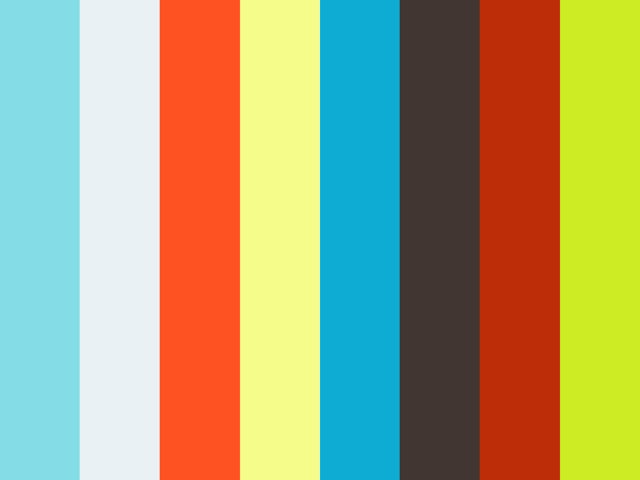





0 Commenti