Un’anticipazione dei principali appuntamenti nazionali da non perdere!
È il nome di un episodio del Satyricon di Petronio: abbiamo indagato su cosa racconta e perché anche una cena moderna può essere definita così

A tavola, si sa, si sta bene e generalmente in compagnia; la cena rappresenta un momento di convivialità, di condivisione e di confronto: i commensali, quello che mangiano, gli argomenti con cui si intrattengono rappresentano lo specchio della società, regalano spesso spaccati di vita, un affresco di tipi, abitudini, tradizioni, e addirittura vizi e virtù… Tutto questo, oggi come ieri: perché a tavola ci si racconta, e la tavola racconta.
È quello che accade nella famosissima Cena di Trimalchione, il lungo episodio (che va dal capitolo 27 al capitolo 78) del celebre Satyricon di Petronio che, a differenza di molta parte del testo, è giunto a noi praticamente integro. Il convivio occupa il centro della narrazione e racconta una cena-spettacolo a casa del liberto Trimalchione cui partecipano, come osservatori, i tre protagonisti dell’opera Encolpio, Ascilto e Gitone. L’episodio, non essenziale allo svolgimento della storia e delle vicende dei protagonisti, rappresenta una pausa, un intermezzo nel quale l’autore offre un vero e proprio spaccato, efficace e al tempo stesso grottesco, della società del tempo. Tutti i personaggi sono la rappresentazione, realistica e a volte caricaturale, delle tipologie umane che animavano la vita delle città del I secolo d.C.
Il protagonista del banchetto, Trimalchione, è l’emblema del servo arricchito, del liberto che, affrancatosi, è riuscito ad accumulare ricchezze da sfoggiare senza consapevolezza e che, di fatto, è rimasto gretto e rozzo nei modi e nel linguaggio. Trimalchione, infatti, rappresenta l’uomo che vorrebbe essere ciò che non è, ciò che non riesce ad essere nonostante l’apparenza e lo sfarzo ostentato. Anche i suoi ospiti tentano invano di improvvisarsi poeti o retori ma esprimono, con il loro linguaggio e le loro azioni, solo la fame di cibo e sesso.
Gli attori della vicenda tentano durante la cena, solo apparentemente, di cimentarsi in discorsi seri ed elevati sul senso della vita e della morte, ma finiscono solo per raccontarsi storie scabrose, persino macabre, abbandonandosi al vino, al linguaggio a volte scurrile e agli incontri erotici. Tutti sembrano essere quello che in realtà non sono, esprimono un tentativo piuttosto goffo di voler elevare le proprie anime e il proprio profilo intellettuale che rimane invece di basso livello e volgare. Il banchetto è narrato infatti attraverso singole scenette nelle quali si susseguono, senza un vero filo logico, racconti di eventi stupefacenti, danze, giochi circensi e vengono servite portate abbondanti e scenografiche in piatti di lusso, addobbati come opere d’arte, tutto in modo eccessivo travalicando la misura e il buon gusto.
Il chiasso e il frastuono, le risa e gli schiamazzi sono la colonna sonora di un banchetto servito su vassoi d’argento, brocche d’oro e di cristallo, in cui anche la moglie di Trimalchione sfoggia l’unica cosa che ha, ossia lo sfarzo dei propri gioielli. Quello che ne deriva è un affresco grottesco dell’umanità (di ieri ma anche di oggi; il Satyricon è più attuale di quanto si possa immaginare), il ritratto del prototipo dell’uomo che, arricchitosi con la fortuna e l’astuzia ma privo di cultura e garbo, è ossessionato solo dal desiderio di apparire ciò che in realtà non è, esprimendo in questo tentativo mal riuscito solamente il peggio di sé.
Ecco spiegato l’uso e al contempo il possibile equivoco generabile dall’attribuire ad un banchetto o ad una pasto conviviale l’accezione di cena di Trimalchione. Se, infatti, da un lato ci si può riferire semplicemente alla fastosità della situazione, agli aspetti gioiosi e goliardici, dall’altro questo paragone potrebbe essere interpretato come una critica pesante ai gusti, ai modi e allo stile del padrone di casa e degli ospiti.
Occhio a “confondersi” con i commensali del liberto petroniano, dandosi arie da gran signori, affermati ma privi di eleganza, buon gusto e misura. Anche l’eccesso delle portate e dei piatti offerti ai convitati potrebbe suscitare un senso di fastidio e sdegno di petroniana memoria, quindi meglio evitare; piuttosto è bene ricordare che la moderazione e la pacatezza del linguaggio sono necessari e adatti ad un momento di condivisione come un banchetto!
Scritto da Viviana Di Salvo
Laureata in lettere con indirizzo storico geografico, affina la sua passione per il territorio e la cultura attraverso l’esperienza come autrice televisiva (Rai e TV2000). Successivamente “prestata” anche al settore della tutela e promozione della salute (collabora con il Ministero della Salute dal 2013), coltiva la passione per la cultura gastronomica, le tradizioni e il buon cibo con un occhio sempre attento al territorio e alle sue specificità antropologiche e ambientali.








































































































































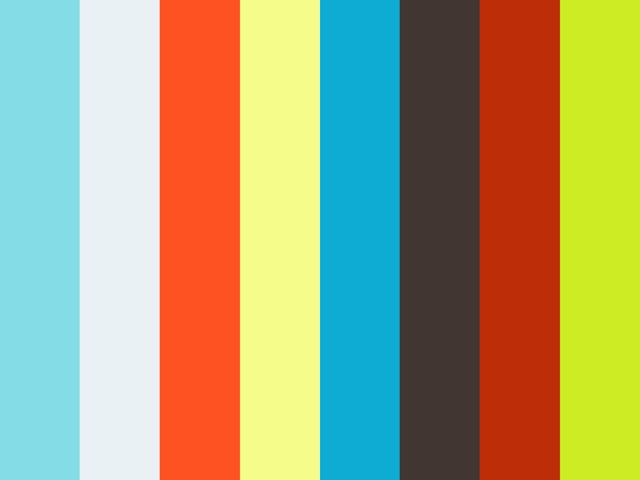
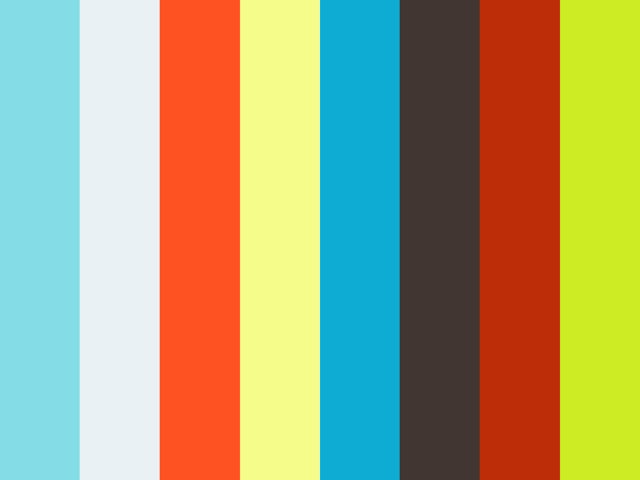
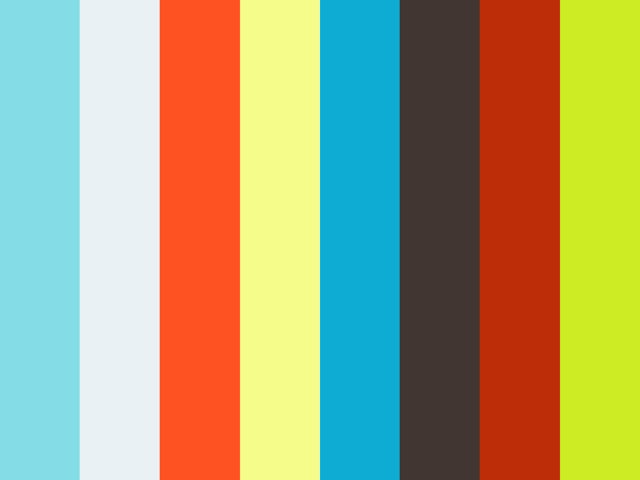
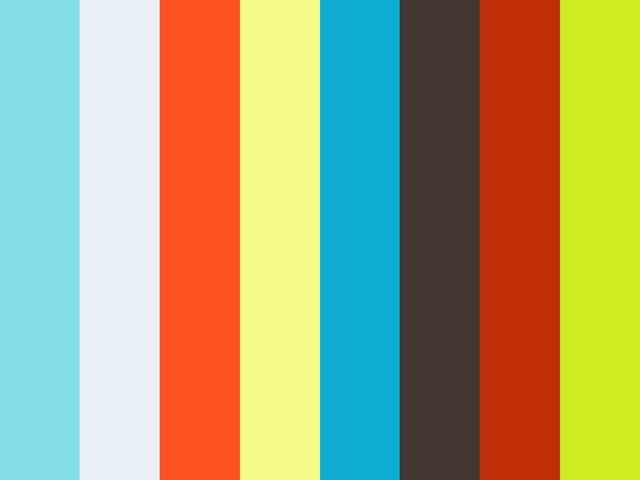
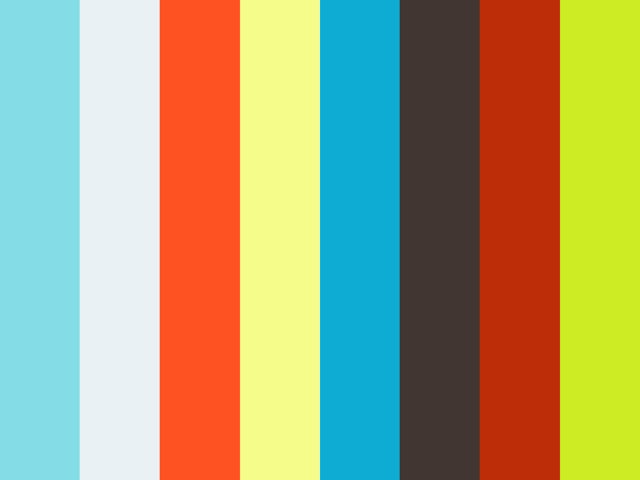
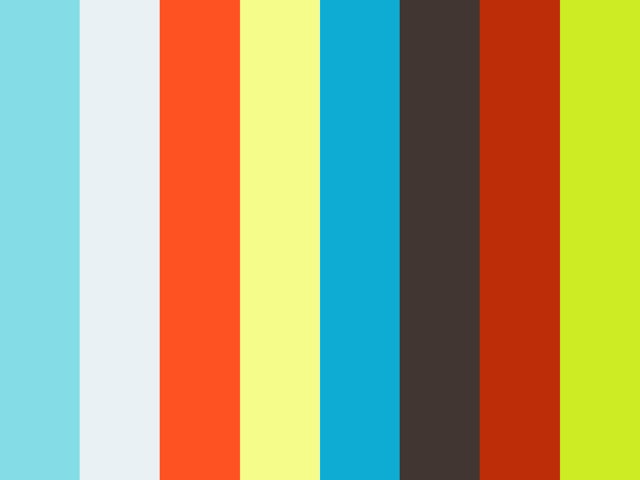

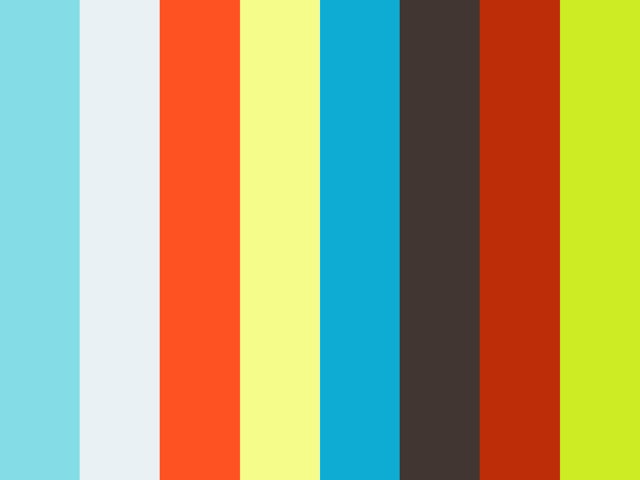

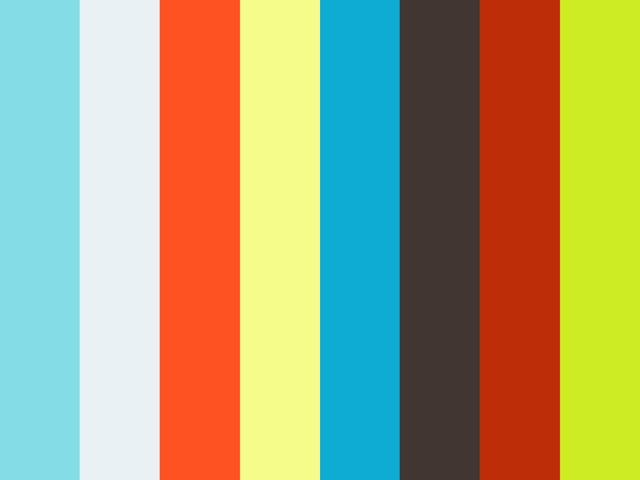
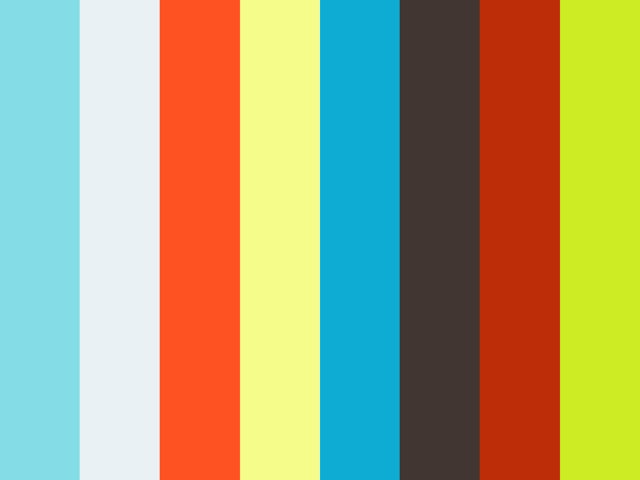
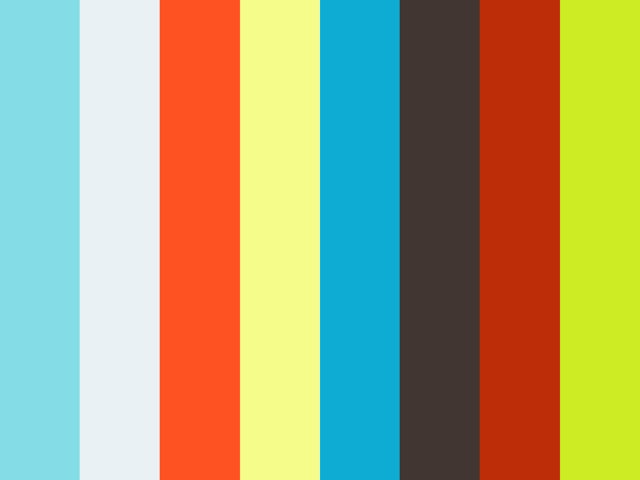
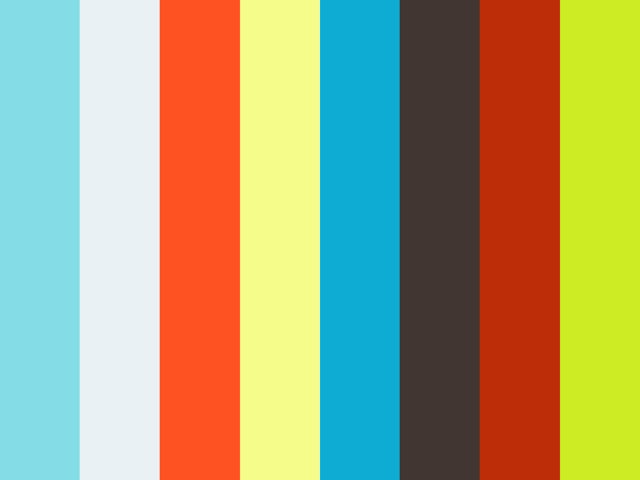
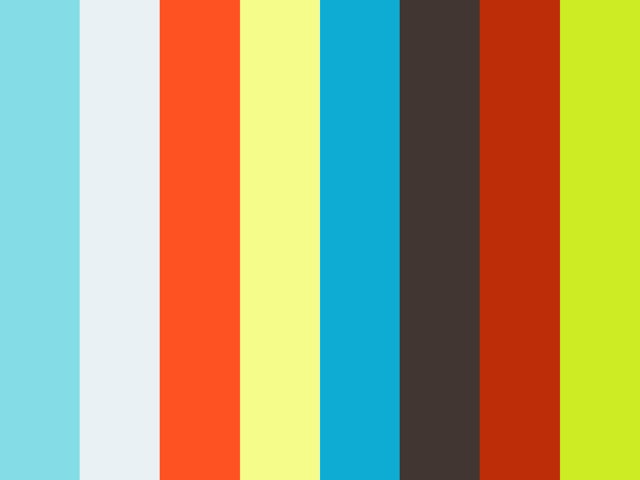
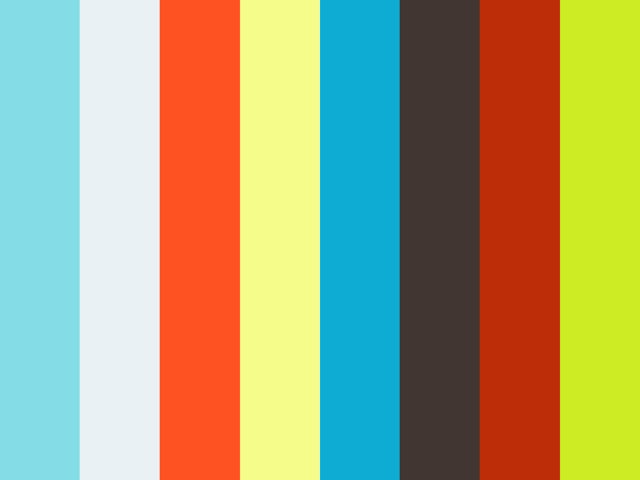
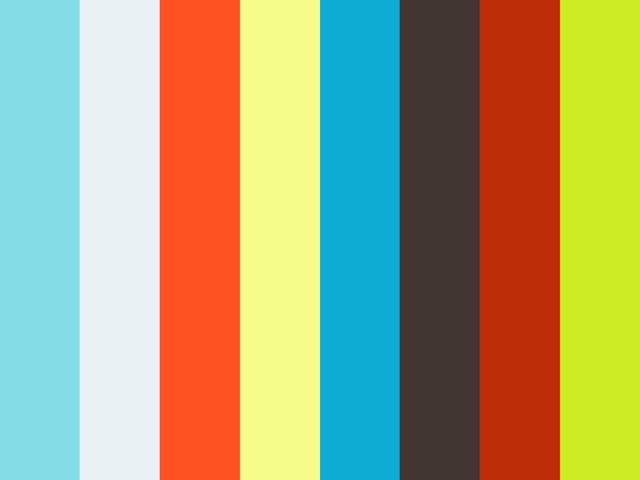
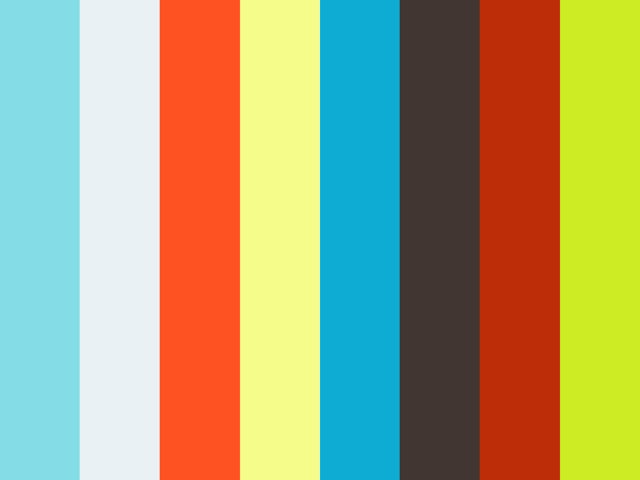





0 Commenti