Alcuni personaggi di fantasia fra i più amati dai bambini di ieri e di oggi hanno un particolare rapporto con l’alimentazione: ricordiamoli insieme
Si tratta del salmone, il cui allevamento intensivo (sempre più spinto dalle forti richieste del mercato) porta a molteplici effetti deleteri

Gli studi hanno ormai dimostrato scientificamente che la carne e il pesce allevati, in condizioni ottimali e nel rispetto delle regole e delle normative di tutela (dell’animale stesso e del consumatore), costituiscono una risorsa preziosa. Diverso è quando ci si riferisce però agli allevamenti intensivi che, per definizione, alterano i tempi, gli spazi e le modalità del fisiologico ciclo di accrescimento e di vita degli animali.
Tra i pesci di allevamento più diffusi ci sono le trote, le carpe, le orate, i branzini e soprattutto i salmoni. Senza voler demonizzare il pesce d’allevamento tout court che non va considerato di serie B, un discorso particolare merita proprio l’allevamento dei salmoni. I salmoni sono pesci carnivori e pertanto solo alimentati con altri pesci o con mangimi ad alta concentrazione di proteine e pescati dopo 12/24 mesi di allevamento; l’acquacoltura del salmone può essere estensiva (detta anche maricoltura), intensiva o addirittura iperintensiva (RAS).
E’ proprio l’alimentazione del pesce che mettiamo nel nostro piatto a costituire la criticità principale degli allevamenti stessi, specie di quelli intensivi e a renderli ormai non più sostenibili: è il pesce pescato e destinato all’alimentazione dei salmoni ad incrementare un circolo vizioso di spreco di risorse utili per l’alimentazione umana, a vantaggio, solo apparente, dell’allevamento in gabbia dei salmoni.
Il disequilibrio che si crea tra il pescato e l’allevato è tale da non giustificare l’attività intensiva sia in termini etici che economici. Il mercato infatti richiede quantità enormi di salmone (nell’arco degli ultimi due decenni la domanda di salmone è aumentata del 270%) per allevare i quali è necessario dirottare “altro pesce”, pescato e anche se di minor pregio, all’alimentazione animale anziché umana. Il mare diventa una sorta di dispensa per gli allevamenti, per cui si rompe l’equilibrio naturale indispensabile al benessere dell’intero ecosistema.
Di fatto, gli allevamenti intensivi di salmoni non sono efficienti perché per ottenere 1 kg di salmone ne servono almeno 5 di altri pesci, cosa che contribuisce alla riduzione degli stock ittici e determina addirittura l’estinzione di alcune specie. Per fare un esempio concreto, nel 2014 sono state utilizzate 460mila tonnellate di pescato (il 76% del quale potenzialmente sfruttabile direttamente per l’alimentazione umana) per produrre 179mila tonnellate di salmone scozzese allevato in modo intensivo: si tratta di un paradosso sia dal punto di vista commerciale che eco-ambientale. La contraddizione più apparente di questo sistema di produzione è che si sottrae al consumatore un quinto del pescato selvatico annuale mondiale (circa 18 milioni di tonnellate annue) per produrre mangimi (in particolare farine e olii di pesce) destinati agli allevamenti intensivi del salmone.
Ciò di cui si nutrono i salmoni nelle vasche di coltura intensiva è, in parte, ciò che mettiamo nel nostro piatto: da un punto di vista più strettamente sanitario, infatti, gli allevamenti intensivi celano rischi occulti e subdoli legati alla proliferazione di agenti patogeni nelle acque di coltura (con rifiuti ed escrementi che si depositano sui fondali delle vasche) e alla presenza di inquinanti (compresi gli antibiotici, gli antiparassitari e i pesticidi) che assorbiti dai salmoni passano poi agli individui umani in proporzione variabile (per esempio i pidocchi di mare assalgono i salmoni arrivando a mangiarli vivi così che diventa inevitabile l’uso di sostanze chimiche per contrastarli e debellarli). Inoltre in questi allevamenti intensivi i salmoni sono alimentati da mangimi “medicati” per contenere la diffusione di virus e batteri.
Si consideri inoltre che il numero di salmoni per vasca di coltura, negli allevamenti intensivi e iperintensivi, è tale da non lasciare spazio di movimento generando sofferenza e stress a degli animali abituati normalmente ad avere spazio e che, ritrovandosi compressi, non riescono a nuotare; questo determina peraltro l’aumento del grasso delle carni (diminuendo di conseguenza i benefici per la salute). Generalmente le gabbie dove vengono tenuti i salmoni sono di forma circolare o quadrata con un diametro medio compreso tra i 10 e i 35 cm una profondità pari a 10 metri; in questo spazio la densità arriva fino a 18 kg per metro cubo, una vera follia!
Anche il colore delle carni nei salmoni da coltura intensiva è soggetto a manipolazione attraverso l’aggiunta di coloranti (non sempre autorizzati) nei mangimi al fine di rendere il colore più acceso e simile a quello dei salmoni selvaggi. L’obiettivo del consumatore (che determina in gran parte l’andamento del mercato) è quello di non cadere nella trappola di un mercato distorto ma scegliere di acquistare pesce pescato o allevato nel rispetto delle regole e della salute per portare nel piatto un prodotto buono, nutriente, eco-sostenibile sia dal punto di vista ambientale che del portafoglio.
Anche dal punto di vista dell’inquinamento gli allevamenti intensivi producono effetti a catena sulle acque perché i rifiuti organici e chimici possono uccidere la vita marina e determinare una cattiva qualità dell’acqua (di mare e di coltura) a causa di fioriture algali dannose e dei riversamento di sostanze chimiche e medicinali pericolose. Ciò che abbiamo voluto mettere in evidenza puntando la lente di ingrandimento sugli allevamenti di salmoni si riferisce ovviamente alle pratiche intensive e iperintensive in cui, al mancato adempimento per le norme vigenti in materia di salute e benessere animale, si aggiunge la mancanza di rispetto per il principio universale di eco-sostenibilità.
Sarebbe auspicabile al contempo il ripopolamento dei salmoni selvatici con l’attuazione di una attenta politica ambientale internazionale.
Scritto da Viviana Di Salvo
Laureata in lettere con indirizzo storico geografico, affina la sua passione per il territorio e la cultura attraverso l’esperienza come autrice televisiva (Rai e TV2000). Successivamente “prestata” anche al settore della tutela e promozione della salute (collabora con il Ministero della Salute dal 2013), coltiva la passione per la cultura gastronomica, le tradizioni e il buon cibo con un occhio sempre attento al territorio e alle sue specificità antropologiche e ambientali.








































































































































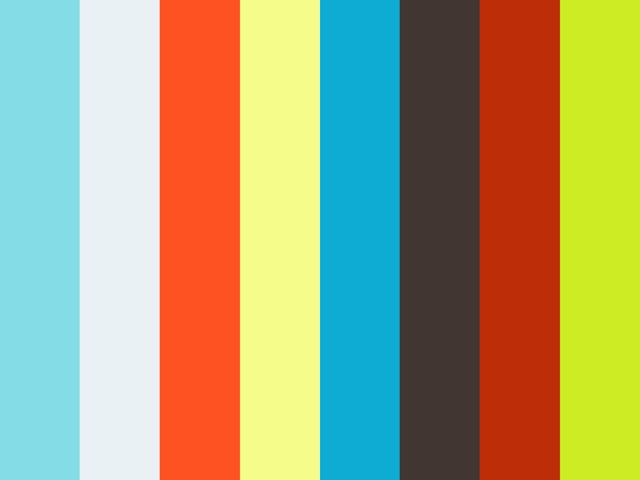
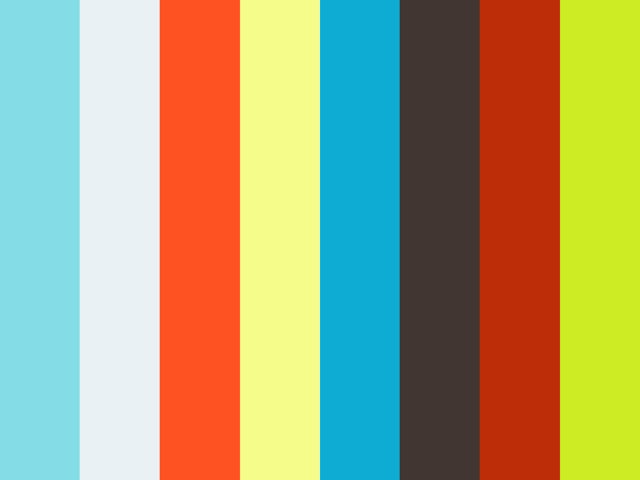
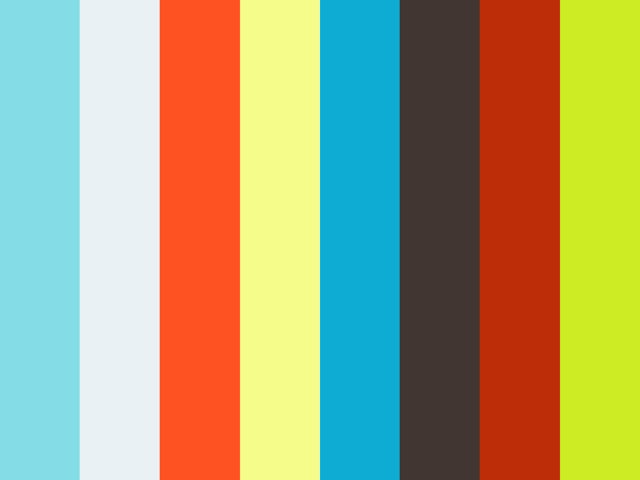
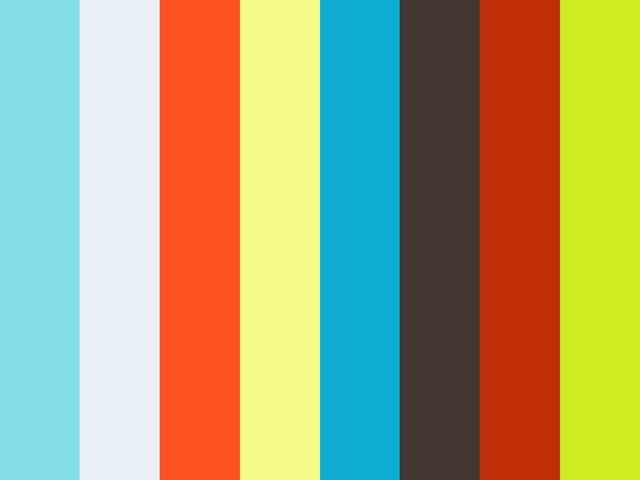
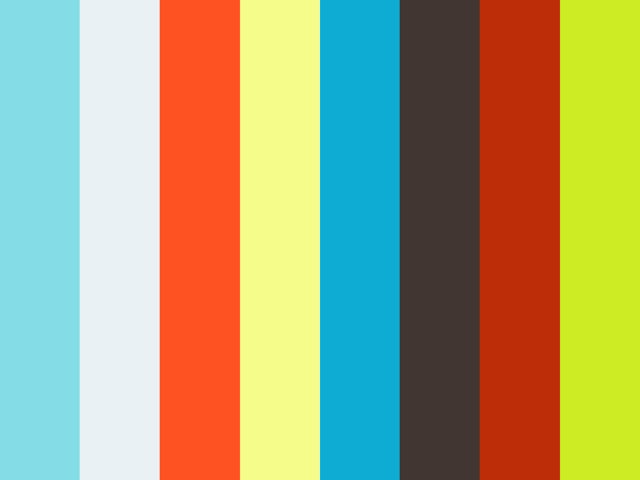
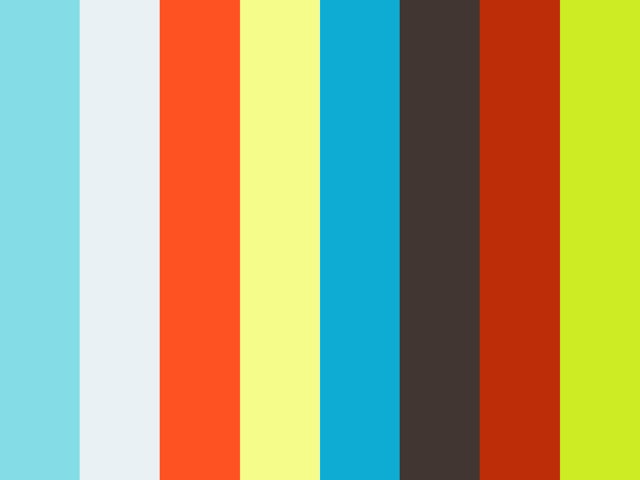

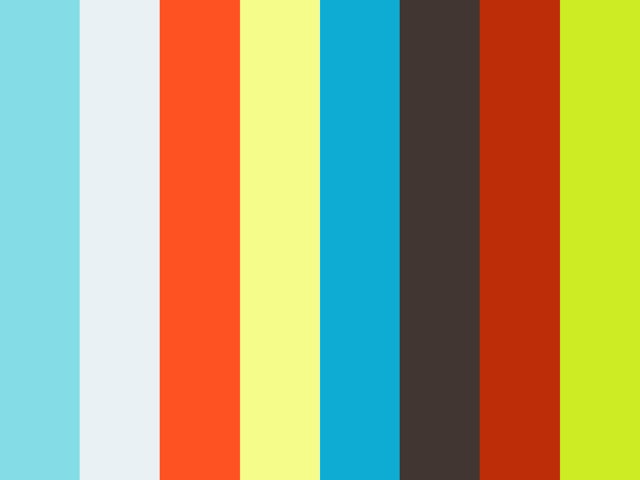

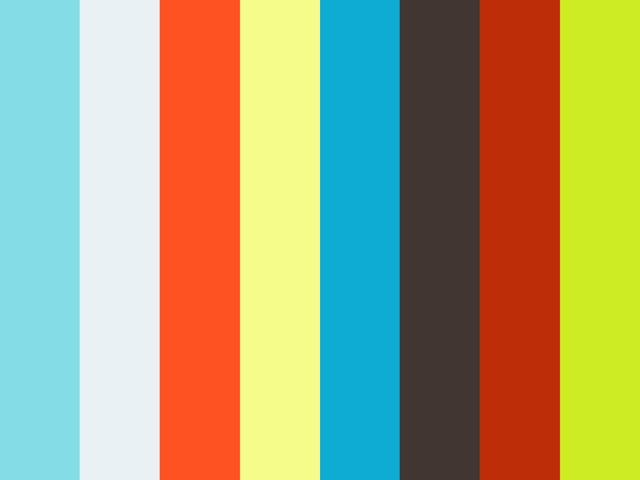
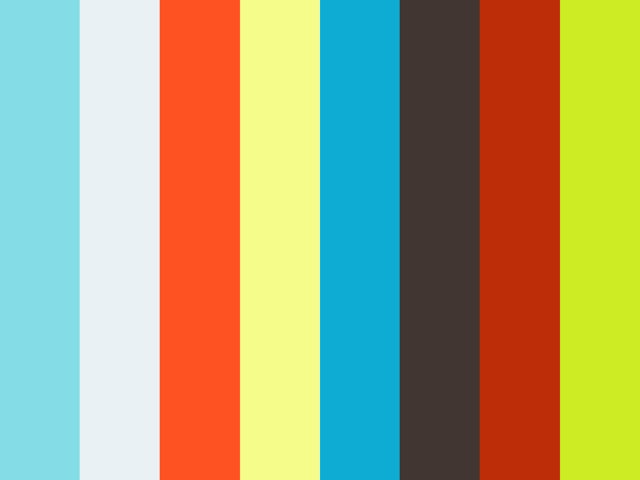
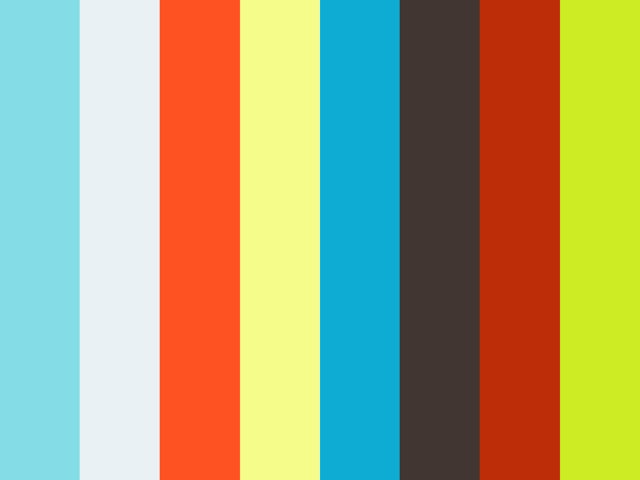
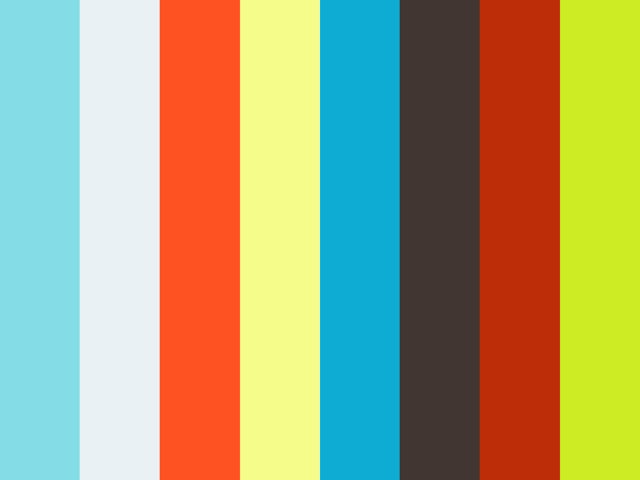
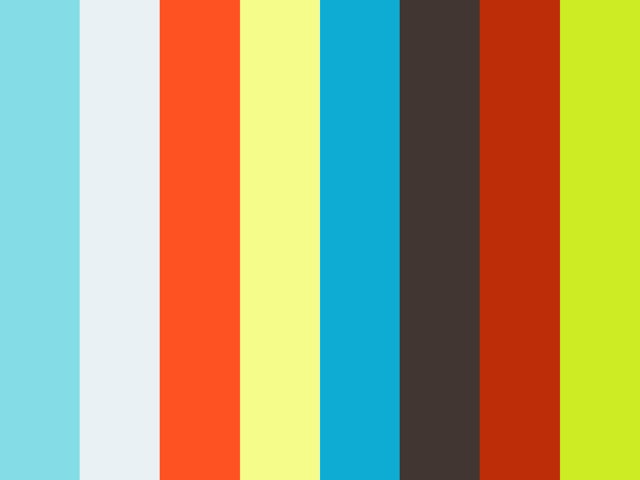
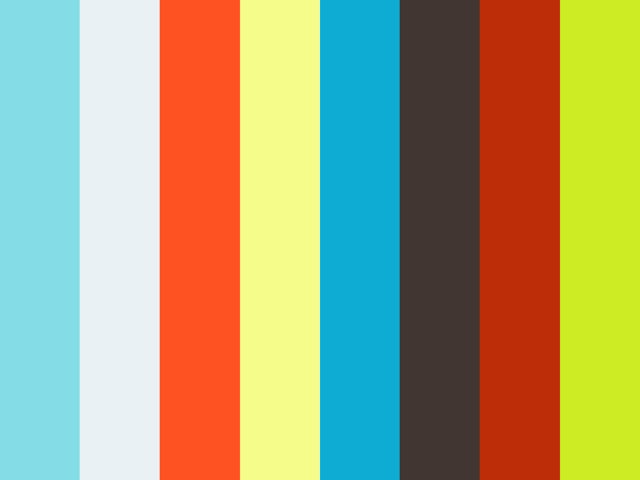
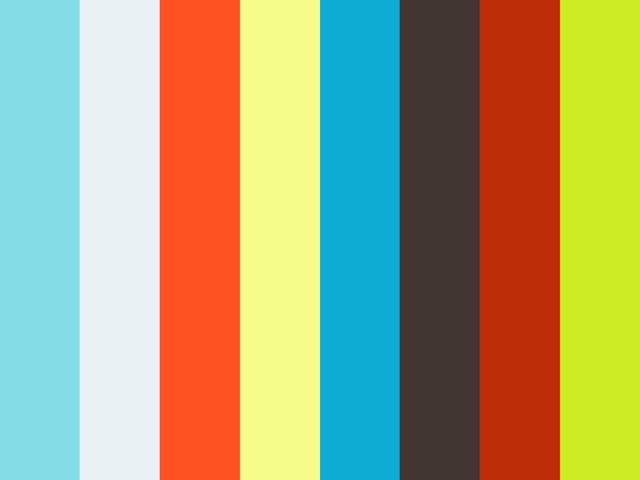
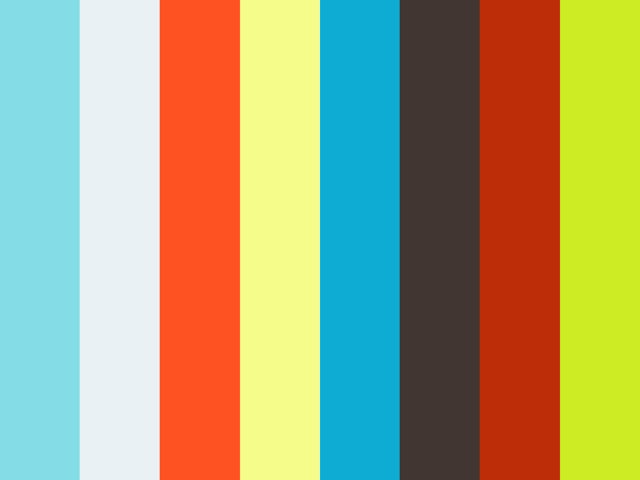





0 Commenti